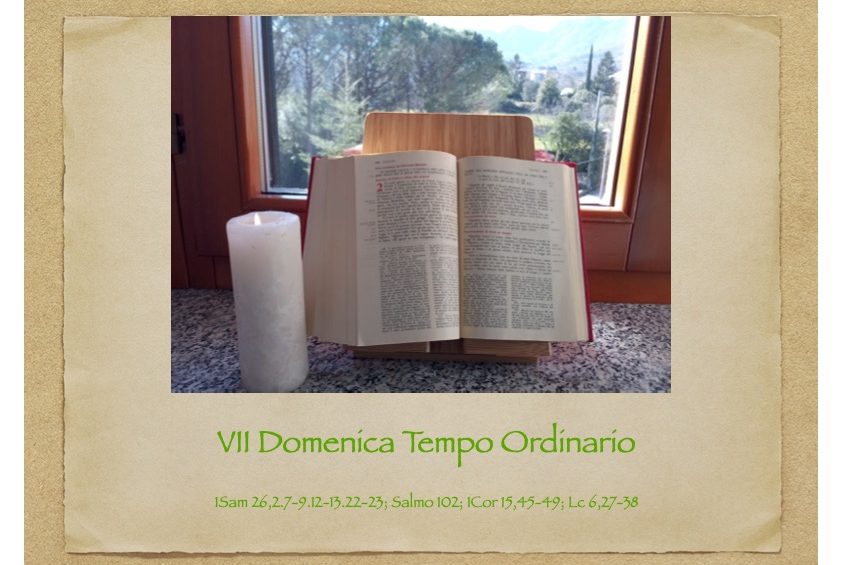
Meditiamo sulla parola – VII Domenica Tempo Ordinario anno C
Il termine “Riconciliazione” ricorre nelle lettere di san Paolo: “Lasciatevi riconciliare”. Riconciliare è il compito proprio dell’apostolo. Il termine, come le lettere di san Paolo, cade presto in disuso. Si deve al Concilio il rinnovato uso del termine. La ricomparsa si può considerare un tentativo di rinnovamento e di riscoperta del sacramento, irrinunciabile per la vita del credente. Alla stessa maniera non si parla più di «estrema unzione»ma di «unzione dei malati».
Il quarto sacramento da sempre è circondato da un alone fosco che comporta un peccato da confessare e una penitenza da scontare. La confessione, ridotta ad una qualsiasi devozione come la recita del rosario o accendere una candela, serve a mettersi a posto e, come si suol dire, a sentirsi in grazia di Dio. Chi confessa mancanze gravi può dare un respiro di sollievo solo quando viene finalmente congedato dal confessore. Di solito la penitenza è del tutto inadeguata al male commesso. Il penitente: “Ho ucciso!” Il confessore: “Dici tre Ave Maria e quattro Padre nostro”.
Il sacramento non incide sul vissuto quotidiano. Dominante è l’immagine di un Dio iroso, giudice inflessibile, ragioniere instancabile dei peccati degli uomini, sempre pronto a pretendere un rendiconto dell’operato umano. Il Concilio pone al centro il volto del Dio di Gesù, misericordioso, lento all’ira, grande nell’amore.
Si è voluto dare una svolta anche attraverso una nuova denominazione. Bisogna ammettere che il tentativo non ha dato i frutti desiderati. Crescente è la disapprovazione, la disaffezione che arriva all’abbandono della confessione o comunque la si voglia chiamare. I praticanti purtroppo non hanno una maggiore consapevolezza del suo valore: sono reso una persona nuova. Nel linguaggio comune, confessione ha una risonanza giuridica, rimane un piccolo processo. È considerato un passaporto per accedere all’Eucaristia. In più, l’uso indiscriminato dell’immagine di Dio misericordioso verso tutti ha finito per trasformarlo in uno che non valuta l’azione umana buona o cattiva che sia: le scelte umane non hanno importanza perché Dio è sempre buono; è indifferente compiere il bene o il male. La dimensione penitenziale, il controllo del desiderio, la disciplina, lo sforzo morale hanno perso il loro significato. Si conclude: il peccato non esiste e quindi non occorrono né confessione né penitenza.
Alcuni preferiscono vedersela direttamente con Dio senza mediazioni. Interessante: in Oriente per evitare che il sacerdote appaia come protagonista, il celebrante e il penitente si pongono l’uno accanto all’altro, in ginocchio, di fronte all’icona di Cristo. Si vuol dire: entrambi sono segnati dalla condizione umana che è condizione di fragilità. Il sacerdote è nella posizione di testimone e compagno di penitenza.
La riconciliazione esige alcuni passaggi che si possono così schematizzare:
- Ho sbagliato nei tuoi confronti: contro di te, contro te solo ho peccato.
- Mi pento di quanto fatto: riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
- Ti chiedo perdono: cancella tutte le mie colpe.
- Mi manchi. Senza di te vivo male. Senza di te non posso vivere.
Riconciliazione è metanoia, cambiamento di mentalità, un inizio nuovo più saldo, più attento, più maturo.
Non un generico “vogliamoci tanto bene”, ma qualcosa di molto più impegnativo. Si tratta di un incontro di più libertà. C’è chi chiede il perdono, c’è chi decide di accoglierlo, chi decide di rifiutarlo.
Se uno dice “faccio ciò che voglio, tanto mia moglie chiude sempre un occhio, se è il caso chiude entrambi”, dimentica. Al di là di ogni tolleranza rimane che la fedeltà non è tradimento, la premura non è violenza, l’attenzione non è disinteresse.
Nel momento della frattura, nel momento delle cicatrici, nell’ora del danno occorre far propria la delicata lezione suggerita da un’antica arte giapponese “kinzugi” sorta nel 1400 ca.
Kinzugi significa “riparare un oggetto rotto”.
Quando una piccola ciotola, un vaso prezioso cadono e si frantumano in mille cocci, noi li buttiamo con rabbia e dispiacere. La pratica giapponese sopra menzionata fa l’esatto opposto. Non butta via, ma evidenzia le fratture rendendole preziose. Quest’arte prescrive l’uso di metallo prezioso e polvere di oro per esaltare le nervature create. La riunione dei frammenti dà un aspetto nuovo grazie alle cicatrici impreziosite. Ogni pezzo riparato diviene unico e irripetibile. Le cicatrici non si nascondono ma diventano bellezza da esibire. Tradizionalmente il collante usato si ricava dalla pianta Rhus. È una linfa appiccicosa nota per le sue qualità adesive.
Il kinzugi suggerisce paralleli suggestivi circa il nostro argomento.
Non si deve buttare ciò che si rompe.
Le rotture non rappresentano la fine.
Le fratture possono diventare trame preziose.
Con il recupero dell’oggetto c’è tutto da guadagnare e niente da perdere.
In questo nostro mondo c’è il male. Tutti ne facciamo esperienza. È importante reagire in maniera positiva: il bicchiere è mezzo pieno.
Le prove possono inacidirci. Possono anche umanizzarci, se lo vogliamo.
Se siamo attenti constatiamo che proprio le prove ci rendono persona umile, nuova, irripetibile, dal valore incalcolabile.
Proviamo… ne vale la pena.