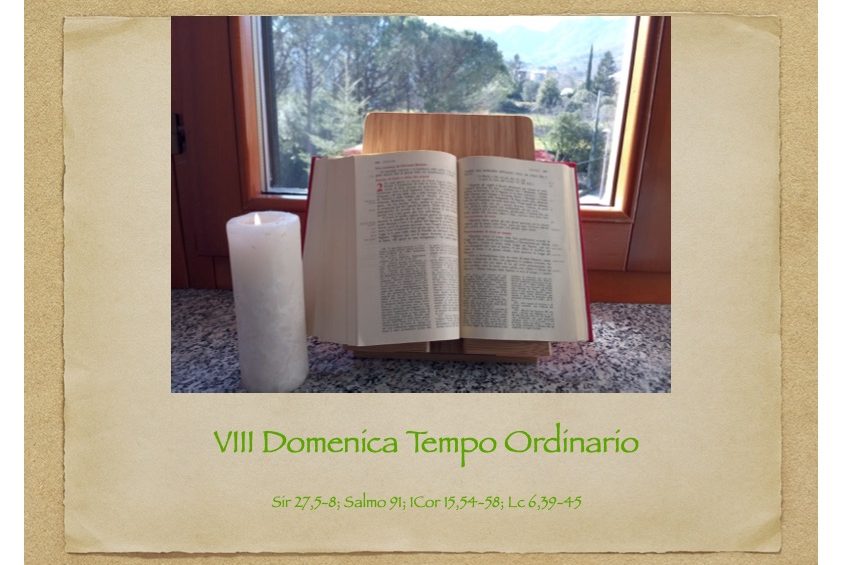
Meditiamo sulla Parola – VIII Domenica Tempo Ordinario – anno C
L’autore della prima lettura elenca i criteri per valutare lo spessore di una persona.
Il Siracide è un libro singolare. Conosciamo il suo autore, la sua professione e l’epoca di composizione. Il titolo originario è “Libro di Ben Sirach”, nella versione latina, il titolo è l’Ecclesiastico. Il libro raccoglie l’insegnamento di uno dei maggiori esponenti del movimento degli Asidei, che si battono contro l’imposizione coatta dei costumi e dell’educazione greca. I suoi scritti stabiliscono un confronto tra giudaismo e mondo greco. Emerge la convinzione che la vera Sophia-Sapienza sta nella Legge di Mosè. Ha una conoscenza che lo porta a superare i confini ristretti del giudaismo.
Per facilitare la comprensione ricorre ad un linguaggio simbolico.
Nella nostra pagina, troviamo i simboli del setaccio, della fornace, dell’albero che dà frutto.
Come quando si scuote un setaccio restano i rifiuti, così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. Il setaccio consente di separare i chicchi di grano dai gambi, trattenendo i primi e scartando i secondi. L’oscurità della coscienza si dirada attraverso la riflessione, proprio come il setaccio separa la pula dal grano.
Come un vasaio prova la consistenza dei vasi nella fornace, così la rettitudine di una persona può essere comprovata a partire dai suoi discorsi. La modalità del discutere e del ragionare palesa i pregi e i difetti. Per misurare la bontà dell’uomo è necessario ascoltare i suoi discorsi, senza lasciarsi ammaliare dai suoi modi, anche raffinati, di porgersi.
Come i frutti mostrano la cura prestata dal contadino, così i ragionamenti di una persona lasciano trasparire la formazione ricevuta: «il frutto dimostra come è coltivato l’albero, così la parola rivela i pensieri del cuore».
C’è l’albero buono ma c’è anche l’albero cattivo. Pensiamo al fico lussureggiante ma spoglio di frutti, condannato dal Signore. Pensiamo alla vite cantata da Isaia: il Signore aveva «atteso che producesse uva ma essa fece uva selvatica». Il nostro impegno è quello di essere albero dai frutti buoni per non essere tagliato e gettato nel fuoco.
Solo dall’ascolto attento è possibile intuire la serietà di chi parla.
La parola viene considerata in tutte le sue forme e in tutte le sue funzioni: la discussione, il ragionamento, l’interiorità, la verità, l’intervento saggio e quello stupido, il riso sguaiato, il giuramento, l’ingiuria, la discrezione, i segreti.
Ogni persona si trova di fronte a più opzioni: il bene e il male, il bene reale e il bene apparente. Nella nostra cultura, le possibilità di scelta si sono moltiplicate. Tante realtà si presentano come buone, ma alla prova dei fatti non lo sono. Occorre costantemente guardarsi dall’ipocrisia di chi senza motivo loda persone false e non sincere.
È costante nella Sacra scrittura l’invito alla coerenza tra parole e condotta di vita.
La sapienza, la capacità non solo di sapere, ma di gustare quanto si conosce, è un dono concesso a chi si conserva nell’umiltà e nella verità.
La verità non è qualcosa che si conquista solo con la conoscenza, ma anche vivendo e amando pienamente. Perciò nessuno può dire: “Io conosco, ho la verità”. Può solo vivere la verità vivendo l’amore. Compito del sapiente è combattere il male.
La Bibbia non cessa di ripeterlo e il salmo 34 lo dice chiaramente: «C’è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene? Preserva la lingua dal male, le labbra da parole bugiarde».
Fare il bene non è sufficiente, occorre prima strapparsi dal male cominciando a prendersi cura della propria lingua. Per il saggio si pone la fatica della scelta: il giusto che è verdeggiante come un albero, alimentato da un torrente, o essere pula che il vento disperde.