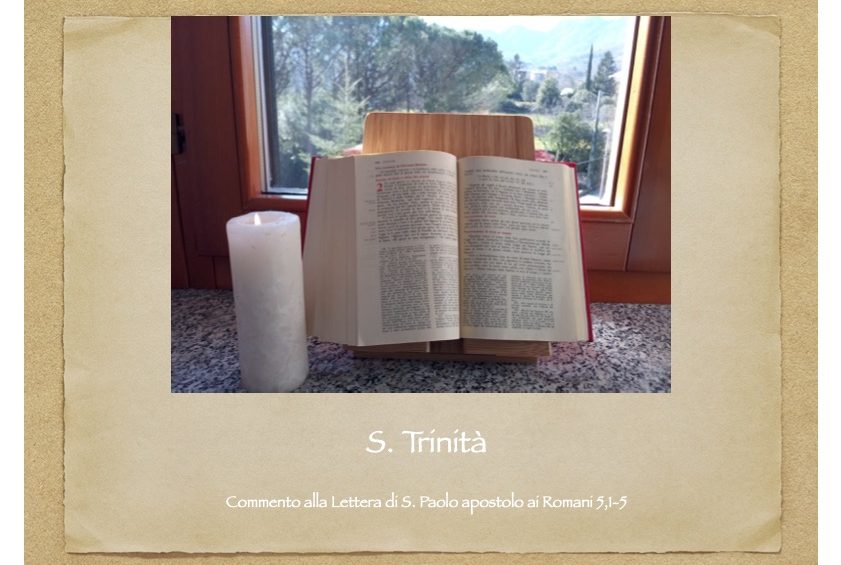
Meditiamo sulla Parola – Commento a Rm 5,1-5
La seconda lettura della liturgia della Trinità è tratta dalla lettera di S. Paolo ai Romani e rappresenta il suo capolavoro, esprimendo più degli altri scritti i suoi concetti fondamentali.
Il mittente si rivolge alla cristianità romana, di cui conosce solo alcuni membri; probabilmente, Paolo scrive verso la fine del suo terzo viaggio missionario, tra il 54 e il 58. Scrive da Corinto, con lo scopo di ricevere accoglienza quando giungerà presso di loro prima di proseguire il viaggio verso la Spagna.
La nostra lettura inizia con questa affermazione: “se siamo stati giustificati per fede siamo in una nuova situazione”. Come a dire: “le cose di prima sono passate”.
Qual è la situazione attuale?
Prima eravamo peccatori, fragili, nemici di Dio. Giustificati, invece, non siamo più nell’inimicizia. La pace è da intendersi in senso biblico (“Shalom”): è la pienezza della benedizione che si riversa copiosa su quanti l’accolgono.
Il nostro brano è continuamente oggetto di studio da parte dei cattolici e della Riforma tutta. Quest’ultima mette l’accento sulla giustificazione, mentre la tradizione cattolica sottolinea la riconciliazione. Non sono due realtà in opposizione, ma una specifica l’altra.
Per riconciliazione si intende una nuova creazione che non elimina, però, le sofferenze, la morte.
Dio nella riconciliazione fa un passo unilaterale verso coloro che sono peccatori. È attuale l’esortazione: “Lasciatevi riconciliare con Dio”. Nonostante le nostre illusioni, non siamo noi che ci riconciliamo, ma Dio che non tiene conto dei nostri peccati.
Questa è la novità cristiana.
Importante la precisazione dell’Apostolo Paolo che non chiede di essere esonerato, ma di sperimentare la liberazione nella buona e nella cattiva sorte. Paolo non dichiara di vantarsi delle ma nelle tribolazioni: egli non va alla ricerca del dolore, ma sa bene che la missione di diffondere il Vangelo riserva non poche sofferenze.
Si tratta di sperimentare la forza del Signore anche e soprattutto nella debolezza.
L’ausilio della grazia divina gli ha permesso di perseverare nelle prove e di temprarsi a ogni fatica affrontata in ragione della predicazione. La sopportazione genera la temperanza, che deriva dalla disponibilità a discernere la volontà di Dio.
In tal modo, non è venuta meno la speranza, senza cedere allo scoramento e alla rassegnazione. Sperare, pertanto, non significa soltanto volgere lo sguardo con fiducia verso il futuro, ma vivere l’ora presente consapevoli di essere sostenuti dalla grazia divina.