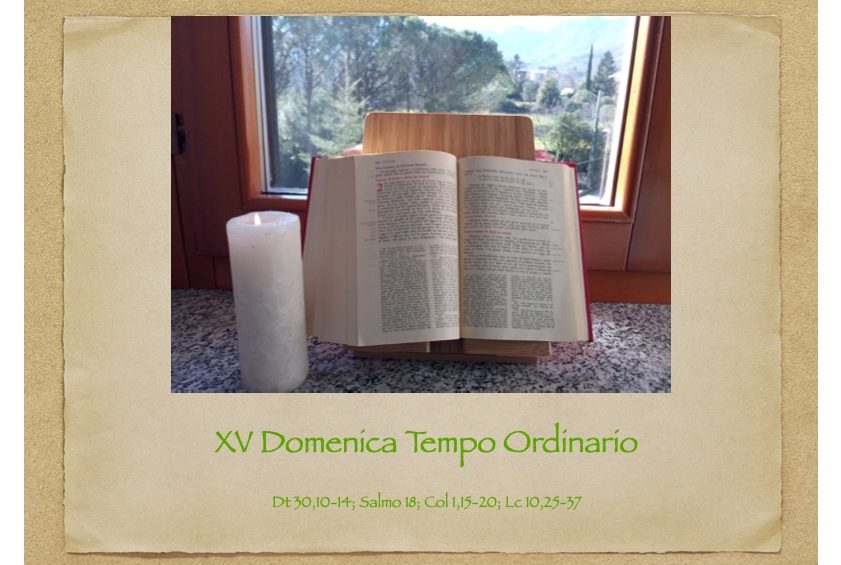
Meditiamo sulla Parola – XV Domenica tempo ordinario anno C
Nella Bibbia parlare della carità significa parlare della giustizia. Le due cose sono inscindibili. Ciò che in italiano chiamiamo carità, in ebraico è zedaqà, cioè giustizia.
I proverbi affermano che la carità libera dalla morte.
Entrando in un rapporto giusto con l’altro, con il suo bisogno, l’uomo entra anche in un rapporto di carità. Occorre fare ciò che è giusto al posto di ciò che piace. Chi si dona, chi si spende per l’altro, viene liberato dalla chiusura che l’opprime, dal ripiegamento su se stesso che lo uccide. Noi siamo salvati grazie e attraverso gli altri.
Aspirare ad essere giusto significa volere essere umano accanto ad altri umani.
Gli insegnamenti contenuti nel Pentateuco sono i testi biblici che meno frequentiamo e conosciamo.
Eppure, è proprio da questi testi che possiamo trarre le ragioni/motivazioni della carità. Il fine della carità è aiutare l’uomo ad avere un cuore di carne e non un cuore di pietra.
Es 22 ss. recita: «non opprimere l’immigrato… anche voi siete stati immigrati in terra d’Egitto». Questo testo richiede un lavoro di approfondimento, un passaggio dall’esteriorità all’interiorità. Si cerca di impedire che la vittima di un tempo possa diventare un oppressore nell’oggi. Ricordando la propria esperienza in terra straniera, ricordando la pesantezza dei ritmi di lavoro che tolgono il respiro, si è invitati a nutrire una vera compassione. Carità è prendere coscienza che l’altro è “altro da me”, ma la sua storia non è estranea alla mia.
Un altro testo (Dt 24,6) recita: «Non prendere in pegno la macina o la mola. Sarebbe come prendere in pegno la vita dell’altro».
Si tratta di oggetti vitali per la sussistenza dell’altro. Non si uccide solo a colpi di coltello ma privando l’altro di oggetti vitali che servono per la sua sussistenza. Non si vogliono dare norme fredde e impersonali ma è un appello all’uomo perché apra il proprio cuore. Non conta il caso ma contano le persone che, come ogni opera d’arte, sono irripetibili, dal valore inestimabile. La legge chiede attenzione alle condizioni reali dell’altro.
Es 22,25-26 afferma: «se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, perché è la sua sola coperta. Altrimenti quando griderà verso di me io lo ascolterò perché sono pietoso».
Si obbedisce veramente alla legge solo se si entra nella sua comprensione profonda. La legge tende a fare di un rapporto creditore–debitore un rapporto tra persone, tra creature umane. La giustizia è tale quando è umana.
La carità mi porta a considerare mia la sofferenza dell’altro. L’universale esperienza della sofferenza deve condurre ognuno di noi non a delegare ma a preoccuparsi di tutto ciò che promuove l’uomo. L’altro è un corpo, è l’icona del trascendente tra gli uomini. I Padri ripetono: “Hai visto un povero, hai visto Dio”.
Per il cristiano la ragione ultima e prima della carità è l’agire di Gesù Cristo che dobbiamo imitare: «Non sono io che vivo ma è Cristo che vive in me».
Luigi Zoja nel suo libro “La morte del prossimo” fa notare che la nostra società elimina la dimensione della prossimità per dare spazio alla dimensione della distanza. Solo il contatto con altri ci mette in contatto con noi stessi.
Avere carità non è sottovalutare il corpo dell’altro. Attraverso il corpo ferito ricostruiamo la storia e, quindi, la dignità di ogni uomo.
Riconoscere la dignità non vuole essere un discorso altisonante ma un discoro che tiene conto della materialità e del cibo, del vestito e del calore nell’accoglienza, dell’affetto nell’ospitalità.
Una prassi di umanità travalica le fedi e le credenze. Tiene conto delle ferite e delle menomazioni e sa fare all’altro ciò che egli vorrebbe fatto a sé. Accogliere implica l’arte dell’incontro, l’arte della relazione, l’arte del vivere. Significa non permettere al cinismo e all’indifferenza di avere la meglio.