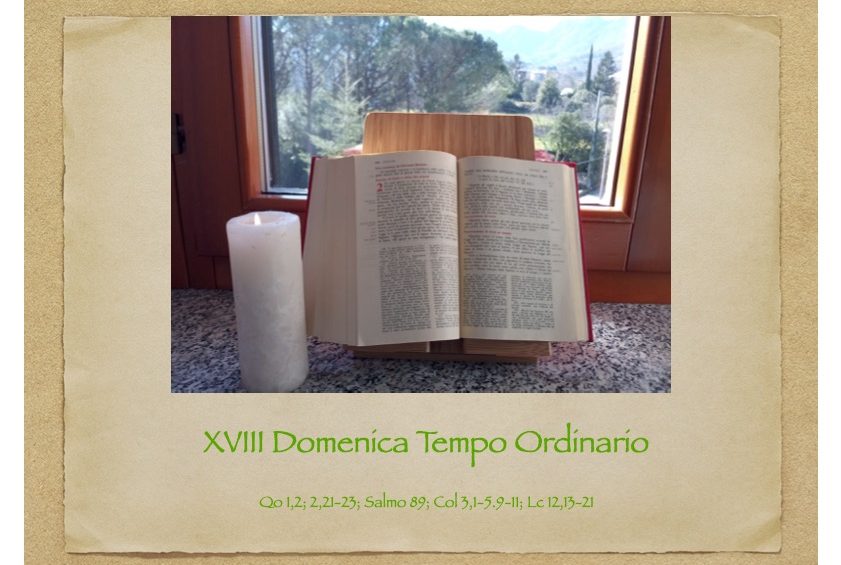
Meditiamo sulla Parola – XVIII Domenica tempo ordinario anno C
Il libro del Qohelet, insieme ai Proverbi, a Giobbe, al Siracide e alla Sapienza, appartiene alla cosiddetta letteratura sapienziale. In quanto saggio ascolta, ricerca, rettifica.
«Ho visto tutto ciò che si fa sotto il sole ed ecco: tutto è soffio, è un inseguire il vento».
Girolamo nella Vulgata, traduzione latina della Bibbia, traduce Qohelet con Ecclesiaste. Lutero preferisce l’appellativo Predicatore. Qohelet dall’ebraico qahal significa una funzione: “Uomo/presidente dell’assemblea / dell’ecclesia”, anche “maestro che parla in pubblico”.
Il libro è opera di un saggio ebreo, che si nasconde dietro la maschera del grande re Salomone. Era consuetudine attribuire la propria opera ad un personaggio illustre che, col passar del tempo, veniva considerato l’autore. Nel nostro caso, il riferimento al re poteva agevolare l’introduzione del libro nel canone.
L’opera, composta da 12 scarni capitoli, quasi certamente è stata scritta verso la metà del III secolo a.C. (150/100), quando Israele viene a contatto con la cultura ellenistica. Il libro si presenta come una raccolta di pensieri organizzati attorno ad alcuni grandi temi. Non speculazione astratta, ma fedele al quotidiano. Il libro del Q. – dice Kafka – serve a rompere il mare di ghiaccio che è dentro di noi. La realtà mediante polarità opposte: «c’è un tempo per demolire e un tempo per costruire; tempo per cercare, tempo per perdere; tempo per parlare, tempo per tacere». Tra questi opposti c’è distanza ma non indifferenza. Il tempo ha un andamento ciclico, bisogna attendere che ritorni su sé stesso. Il mondo ha i suoi ritmi e l’uomo può percepire una parte ma non il tutto.
La prima scoperta: «Tutto è hevel» ovvero un «soffio, assoluto soffio».
Soffio/hevel ci ricorda Abele, una vita brevissima simile ad un alito fuggente.
Il termine ebraico hevel, estremamente suggestivo, allude alla transitorietà del vapore… è impalpabile. La realtà è transitoria, effimera e inconsistente.
Per esasperare il suo messaggio ricorre al superlativo: Hevel, hevelin, soffio dei soffi.
Tradurre è tradire. Ad un certo punto della storia, il termine Hevel è diventato Vanità. Ciò che è fugace diventa cattivo. Vanità porta ad incoraggiare la fuga dal mondo, ingenera pessimismo, scetticismo. Si può arrivare persino alla negazione di Dio.
La nostra è una conoscenza progressiva, ma non esauriente. Dopo il battente negativo si passa a quello positivo. La gioia è l’imperativo categorico. Paolo ripete: «Ve lo comando: siate nella gioia». Non una gioia a fior di pelle, ma un’esperienza tangibile e corposa. Il mistero di Dio va accettato nella sua radicale incomprensibilità. È presente nelle piccole gioie. Abbiamo di mira il lucro e trascuriamo la sapienza; sappiamo accumulare, ma non conosciamo la gioia.
Non possiamo avere certezze assolute, ma possiamo trovare buone ragioni per vivere. La vita non è esente dal conflitto, dalla delusione e dal dolore. È importante accettare i limiti.
Il Qohelet è letto nel terzo giorno della festa di Sukkot o delle Capanne. In questa festa si abita in fragili capanne, identitarie della condizione umana. Esse sono costruite sotto le stelle. Dobbiamo uscire dalle nostre quattro mura, apparentemente sicure.
Cosa resta? Resta il timore. Il timore di Dio non equivale a paura, ma è una dimensione dell’amore.
Un esegeta francese, Maillot, dice: dalla lettura del Q. non si esce indenni, ma adulti o pronti a diventarlo