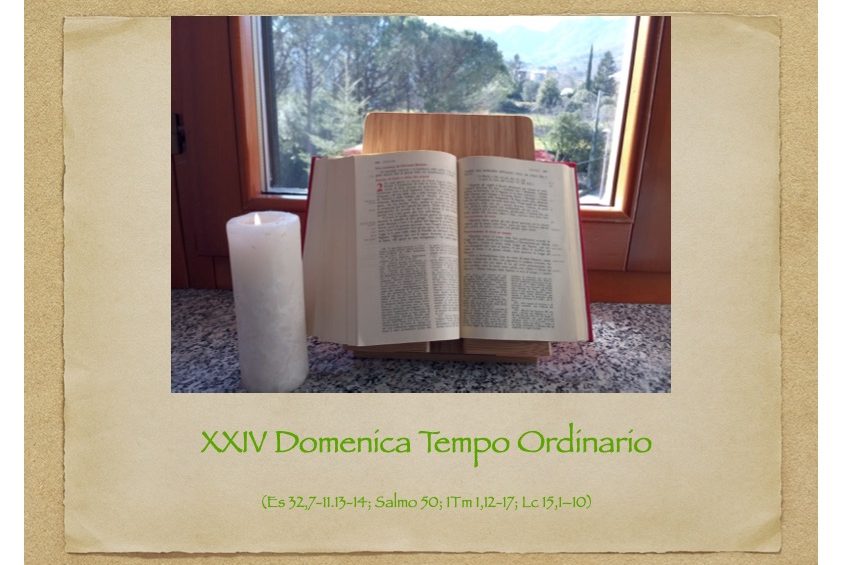
Meditiamo sulla Parola – XXIV Domenica tempo ordinario anno c
Iniziamo la nostra meditazione ponendoci alcuni interrogativi:
- Dio appartiene solo ai giusti o anche ai peccatori?
- L’iniziativa del ritorno è di Dio o del peccatore?
- L’amore di Dio va meritato o è gratuito?
- Cosa è la salvezza?
Nell’AT, meglio nel Primo Testamento, chi vede Dio muore. Nel NT Giovanni, nel prologo chiarisce: «Dio nessuno l’ha mai visto, ma il Figlio unigenito ce lo ha raccontato (exeghésato)».
Il Figlio dell’Uomo narra il volto di Dio con la sua vita: comportamenti, sentimenti e parole.
L’amore di Dio è verso tutti ed è unilaterale. Dio ama l’uomo mentre è peccatore, quando gli è nemico, quando lo bestemmia, lo rigetta. È un Padre che dà la vita vera, chiama, guida, educa, salva. Nessun uomo è irrimediabilmente perduto.
Con amarezza, Gesù deve constatare che il volto del Creatore è deturpato da uomini inclini a farne un manufatto. È convinzione comune che se compio atti meritori agli occhi della divinità, alla fine devo avere qualcosa in cambio, un risarcimento. Questa logica dello scambio non ha niente a che vedere con il cristianesimo. Gesù vuole distruggere, capovolgere questa mentalità perversa, anche se è mentalità comune. Per questo è accusato di essere un bestemmiatore.
Gesù annuncia un altro Dio che non fa preferenza di persone, non castiga, perdona anche chi non lo merita, promuove la libertà di tutti, ha fiducia nell’uomo. Questo conflitto sull’immagine o volto di Dio, è l’antefatto di un processo e di una condanna a morte da parte delle autorità religiose e politiche.
Luca nel c. 15 con una parabola in tre tempi (pecora-dracma-figlio ritrovato) vuole mettere in evidenza il conflitto nel quale vive il Figlio dell’Uomo.
A peggiorare la situazione si registra l’inserimento di Levi-Matteo nella cerchia dei discepoli.
Levi è un pubblicano e peccatore manifesto, collabora con gli occupanti romani, è esattore delle tasse per l’impero. La sua è una vita non segnata dalla giustizia.
Altro motivo di scandalo: Gesù partecipa ad un banchetto in casa di Levi i cui convitati sono quasi tutti pubblicani. Alla reazione mormorante, Gesù dà una risposta chiara: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico ma i malati».
Gesù rimane fedele a questo stile fino alla fine. Muore annoverato tra gli empi.
Per un ebreo, spezzare il pane, significa fare comunione con Dio. Ne consegue che mangiare con i peccatori è un sacrilegio. Per gli uomini religiosi, si può sedere a tavola solo se riconciliati con Dio. Il Nazareno è pronto a spezzare il pane con tutti, abbattendo le barriere.
Gli uomini religiosi invocano il castigo dei peccatori evocando il salmo 139 «Dio sopprimi il malvagio».
Il padre lascia che il figlio se ne vada; non lo costringe col rimprovero. Chi ama non fa violenza.
Inutile farsi illusioni: ritorna (teshuvà) non perché ha riconosciuto il male, ma solo perché spinto dalla fame e dal bisogno.
«Ebbe compassione». Il termine originale greco indica il movimento delle viscere materne. Il padre non chiede nulla, non pone condizioni, non rimprovera, non vuole suscitare sensi di colpa. Ama. Questo è il suo unico motivo.
La Bibbia della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) traduce «la veste più bella», ma si potrebbe tradurre con “prima veste”. Il riferimento è alla veste di Adamo, il primo uomo, perché questo figlio è ricreato, perché l’amore è un atto di ricreazione.
Anche l’anello ha un significato importante, perché sull’anello c’è il sigillo, simbolo della casata. Equivale alla nostra garanzia.
Infine, gli dà anche i sandali. Il figlio è tornato scalzo; in quel contesto solo gli schiavi andavano scalzi. Con questo gesto il Padre sottolinea che non è più schiavo, ma figlio.
La parabola finisce in modo aperto. Non c’è una conclusione. Non è detto se il figlio entra o rimane fuori.
La domanda è rivolta ai lettori di ogni tempo: Entri nella sala della festa o rovini la festa?