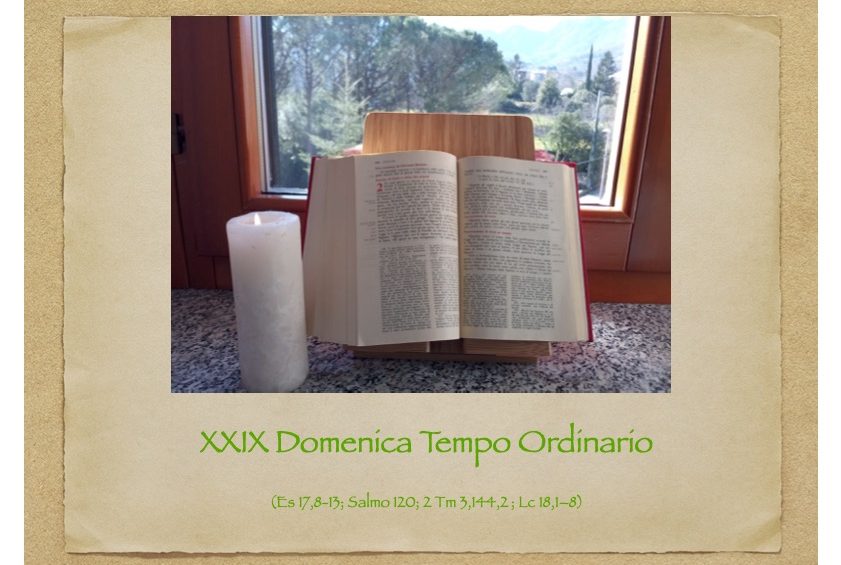
Meditiamo sulla Parola – XXIX Domenica tempo ordinario anno C
Prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II, aperto l’11 ottobre del 1962 da Papa Giovanni XXIII, hanno un ruolo decisivo la ritualità e il rito.
Non si parla di liturgia, ma di sacre cerimonie. Queste ultime sono la materia obbligatoria nella formazione dei futuri sacerdoti. Le rubriche contengono le norme da eseguire scrupolosamente, sono come un galateo che regola tutto: i gesti, i movimenti, i tempi. Un’altra materia di studio è la sacra eloquenza con cui si insegna al futuro presbitero l’arte dell’oratoria. L’esegesi e lo studio della Bibbia sono relegati tra le materie minori.
Si arriva all’assurdo che la messa è considerata valida dall’offertorio in poi (oggi non si parla più di offertorio, ma di presentazione delle offerte, perché non offriamo niente a Dio, ma riceviamo tutto da Lui, autore di ogni cosa). Alla prima parte della messa si può partecipare o non partecipare. Il salmo di ingresso, l’atto penitenziale, le letture, il Vangelo sono secondarie. È ritenuta particolarmente importante la formula della consacrazione, sillabata scrupolosamente dal celebrante.
È sufficiente assistere – sentir messa come ad un teatro, basta la presenza fisica. L’Eucaristia è considerata un fatto privato. Pregare è un pedaggio da assolvere, un obbligo dovuto. Si offrono a Dio una serie di gesti formali in cambio della sua benevolenza. La domenica, la messa è celebrata ogni ora per dare a tutti la possibilità di soddisfare il precetto. Cosi le chiese diventano un messificio. Ma ciò che è ripetuto all’infinito, perde valore.
Il chierichetto suona il campanello due volte: la prima volta al momento della consacrazione, la seconda volta alla comunione.
La preghiera è esclusivamente di domanda, di richiesta: dalla salute alla pace, dalla riuscita di un esame o di un concorso ed altro ancora. Questa rende Dio una specie di tappabuchi: deve compiere quanto noi non siamo in grado di realizzare. Abbiamo la pretesa di far cambiare idea a Dio, mentre siamo noi che dobbiamo cambiare (metanoia).
Eppure, le Sante Scritture continuamente ci mettono in guardia dal non confondere il Dio dell’alleanza con gli idoli alienanti. In Romani 8,26 l’Apostolo afferma: «Noi non sappiamo come pregare in modo conveniente».
È facile confondere la preghiera con un bisogno psicologico di protezione. Crediamo di pregare, ma stiamo solo parlando con noi stessi.
Francesco d’Assisi non dice preghiere, ma è lui stesso preghiera perché ama Gesù e il suo messaggio “sine glossa”, cioè senza condizioni e a fondo perduto.
Non vanno mai offerti gli scarti, ma le scelte di prima qualità.
Si tratta di vedere la vita con gli occhi dell’Amato; è il collirio che ci fa vedere con lo sguardo dello Spirito.
Costituisce un ostacolo la sicurezza esteriore ed effimera, solo l’umiltà diventa l’alimento della ricerca. Caratteristica della preghiera è il dubbio che protegge Dio dal rischio di trasformarsi in idolo.
Siamo talmente presi da mille cose da non avere tempo per l’ascolto. I rabbini affermano: «La bestemmia del nostro tempo è dire “non ho tempo”».
Se le parole si accavallano, si inseguono frettolosamente per giungere alla fine, si compie un rito ma non una celebrazione. Dove non c’è silenzio non esiste senso.
Non siamo chiamati ad ottemperare un obbligo, ma a lodare/ringraziare colui che è presente, anche se invisibile.
Si tratta di stabilire una intimità senza tornaconto, di offrire tutto, ogni gesto, ogni scelta, ogni alito dell’esistenza, anche le cose più banali della nostra quotidianità. Le mille azioni che riteniamo inutili sono anch’esse motivo di benedizione.
Una Messa strapazzata aggiunge vuoto a vuoto, produce disaffezione, allontanamento e disinteresse.
Non sia vano il nostro bussare alla tua porta, perché anche una porta chiusa può essere un atto di amore.