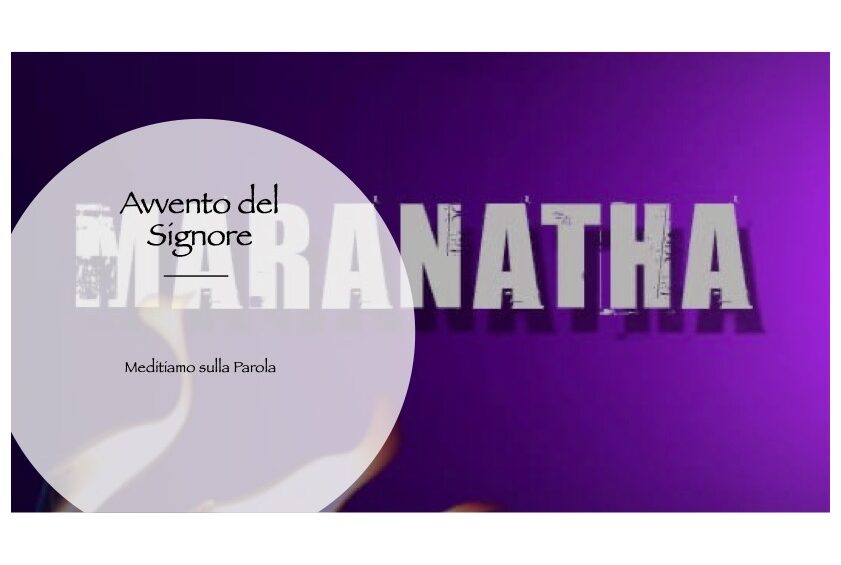
Meditiamo sulla Parola – III Domenica di Avvento anno A
Nella fuga in Egitto la famiglia di Nazareth sperimenta la condizione del migrante perseguitato. Ancora oggi tanti nostri fratelli vivono la medesima ingiustizia per la prepotenza dei potenti.
Il re Erode viene a sapere dai Magi della nascita del re dei giudei. La notizia lo sconvolge e concepisce un proposito scellerato: uccidere tutti i bambini di Betlemme dai 2 anni in giù. Un angelo a Giuseppe: “Alzati, prendi il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode, infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo”.
Giuseppe ed Erode sono due personalità opposte. Per Erode le persone non valgono, non contano niente; per vincere la paura esercita in maniera dispotica il suo potere. In questo atteggiamento possiamo cadere anche noi quando cerchiamo di scacciare la paura usando prepotenza. Non illudiamoci, ciascuno corre il rischio di diventare un piccolo Erode.
Erode è un dittatore, Giuseppe è un uomo giusto. Gesù insegna che l’unica reazione possibile davanti alla violenza è la mansuetudine: “Ora io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti percuote la guancia destra, porgigli anche l’altra”. Possiamo sentirci minacciati, ma non è tirando il peggio di noi che possiamo superare le avversità. Giuseppe è l’esempio di chi forgia il suo carattere con la forza vincente della pazienza, la virtù dei forti.
Per comprendere la paternità di Giuseppe, occorre sapere che nell’antico oriente l’adozione era molto frequente. Il padre ufficiale ha il diritto di imporre il nome al figlio, lo riconosce giuridicamente anche se non l’ha generato. Il nome può essere cambiato perché deve indicare l’identità della persona che lo porta. Il nome Abramo diventa Abraham che significa “padre di molti”. Difatti, Abramo è riconosciuto padre dagli Ebrei, dai Cristiani e dai Musulmani. Gesù significa: “Il Signore salva”.
Secondo gli studiosi la nostra civiltà è orfana di padri perché non basta mettere al mondo un figlio per essere genitore. Padre è chi si prende responsabilmente cura dell’altro introducendolo all’esperienza della vita e della realtà. Quello del padre è un amore liberante, accetta l’altro in ciò che ha di positivo e di negativo. Fa di tutto perché l’altro diventi pienamente sé stesso. Un amore che si risolve nel possedere è egoismo. Gesù scopre la paternità di Dio attraverso quella di Giuseppe.
Gesù pratica il mestiere di Giuseppe. Il termine greco tekton usato per indicare il lavoro di Giuseppe è stato tradotto in vari modi. I padri latini traducono “falegname”. Bisogna tener presente che nella Palestina al tempo di Gesù il legno serve non solo a fabbricare aratri e mobili vari, ma anche a costruire case. Falegname o carpentiere è una qualifica generica che indica sia gli artigiani del legno, sia gli operai impegnati nell’edilizia. È un lavoro duro che comporta la trasformazione del legno, della pietra e del ferro. Quando i genitori presentano Gesù al tempio offrono una coppia di tortore e di colombe che è l’offerta dei poveri.
La riflessione sulla santa famiglia ci porta a considerare il mondo del lavoro, in particolare quei lavori usuranti come quello che si svolge nelle miniere.
Come non ricordare Sebastiao Salgado e la miniera inferno di Serra Pelada in Brasile, coloro che sono sfruttati con lavoro nero, i bambini che sono costretti a lavorare e quelli che frugano nelle discariche per cercare qualcosa di utile da barattare. Efficace è la missione di Zanotelli in Kenia.
Pensiamo a quanti sono feriti nella loro dignità perché non trovano lavoro. Il lavoro è un’unzione di dignità, è una componente essenziale della vita umana. L’operosità impedisce di ridurre la vita spirituale a uno spiritualismo astratto. È un modo per esercitare la nostra creatività. È di conforto pensare che Gesù abbia appreso l’arte proprio da Giuseppe. Come cristiani dobbiamo riscattare il lavoro dalla logica del mero profitto per sentirlo diritto e dovere fondamentale della persona.