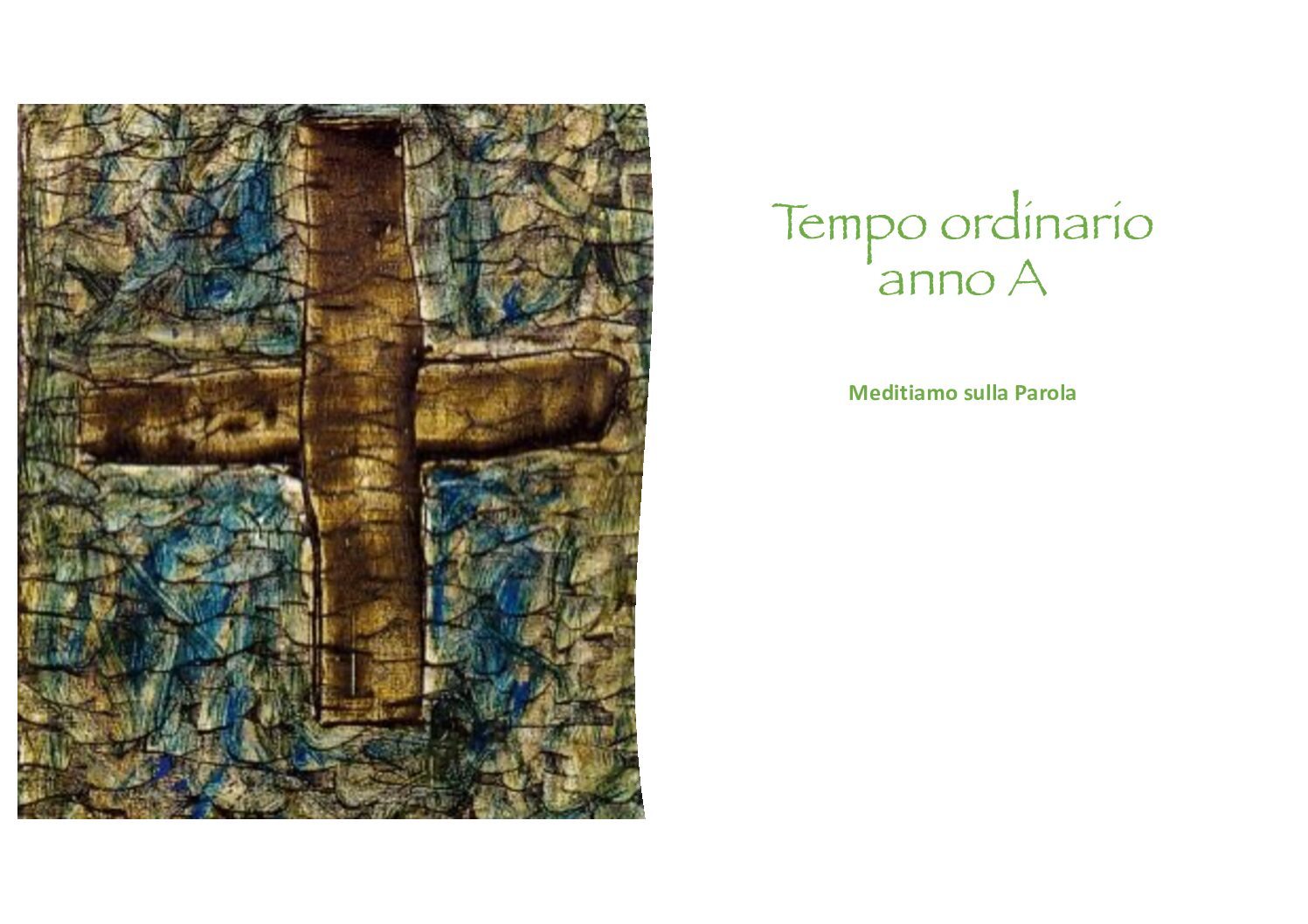
Meditiamo sulla Parola – XI Domenica tempo ordinario anno A
È utile confrontarsi con una domanda decisiva: cosa sono i segni sacramentali? Cosa producono? Per rispondere correttamente alla domanda, il nostro io deve saper entrare in una zona d’ombra, deve accettare di essere messo tra parentesi.
Paolo, in diverse sue lettere, parla della necessità di svuotarsi (kenosi). Gradualmente deve rivelarsi il Cristo presente in noi, deve mostrarsi nelle nostre parole e nel nostro operato. Non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Il segno per eccellenza è il Cristo vivo. I gesti della liturgia non trasmettono potere, ma comunicano salvezza. Il segno liturgico ha una funzione rivelativa. Le nostre parole non sono solo umane, ma sono suggerite dallo Spirito di Dio. Occorre dare spazio alla Parola, ai gesti che giungono a noi attraverso generazioni millenarie.
Siamo collegati con le origini della Chiesa, siamo il punto di arrivo di una tradizione ininterrotta che parte da Gesù e, attraverso Pietro, Giacomo, Giovanni e i 12 apostoli, arriva fino a noi. Non è la trasmissione di una tradizione morta ma, grazie anche alla nostra collaborazione, diventa un messaggio forte, ricco e vivo.
Una chiesa degna di questo nome ha come suo fine principale il servizio dell’uomo (annuin). La comunità cristiana non pretende di essere servita, ma di servire sempre tutti, senza differenza. Dio, nella sua infinita misericordia, consacra il suo popolo e lo invia ad una missione ecumenica.
Non siamo dei privilegiati, non siamo alla ricerca di piccoli o grandi vantaggi, ma dobbiamo essere segno efficace di colui che è morto e risorto. Dobbiamo avere grande riconoscenza e ammirazione per coloro che, in ogni tempo, hanno avuto il coraggio della testimonianza (marturia).
Oggi purtroppo percorriamo vie opposte: vogliamo essere serviti più che servire. Siamo disponibili a comandare, ad opprimere, a possedere più degli altri, rifiutiamo con decisione una vita umile e perciò nuova ed inedita. Manca la convinzione che è più bello dare che ricevere. Tutto questo richiede stile: si tratta di fare bene il bene. Il servizio evangelico va praticato con strumenti semplici, con mezzi evangelici. Al cristiano non è consentito vedere il bicchiere sempre mezzo vuoto.
Le nostre comunità devono mettere in primo piano il servizio di consolazione e di incoraggiamento. Perché questo avvenga, si richiede la disponibilità alla riconciliazione. Riconciliazione è parola greca: “katallege”. Nel cuore di questa parola riscontriamo “allos” che significa altro. La riconciliazione (diventare altro) è cosa rara nel mondo e anche nella Bibbia. Nella Scrittura ci sono solo due racconti che parlano di riconciliazione: quello di Esaù e Giacobbe e quello tra Giuseppe e i suoi fratelli. Sono solo due narrazioni perché la riconciliazione nei nostri ambienti, è inesistente. Mai come oggi è veramente difficile diventare altro, amiamo essere sempre gli stessi.
La notte, prima di incontrare il fratello, Giacobbe fa una esperienza straordinaria: scopre la sua lotta con Dio. Il testo sembra dire: se vuoi arrivare al fratello, occorre passare attraverso Dio. Secondo molti pregiudizi, la sequela viene considerata rinuncia, solitudine, disciplina del corpo e dello spirito, austerità. Al contrario, è un’opportunità per essere chiamati alla gioia, alla serenità, alla contentezza, alla pienezza di vita.
Il Signore con la sua potenza trasformi la nostra vita, ci faccia vivere nella gioia e quanto abbiamo espresso con le labbra possa passare nel nostro cuore e, infine, nella nostra vita.