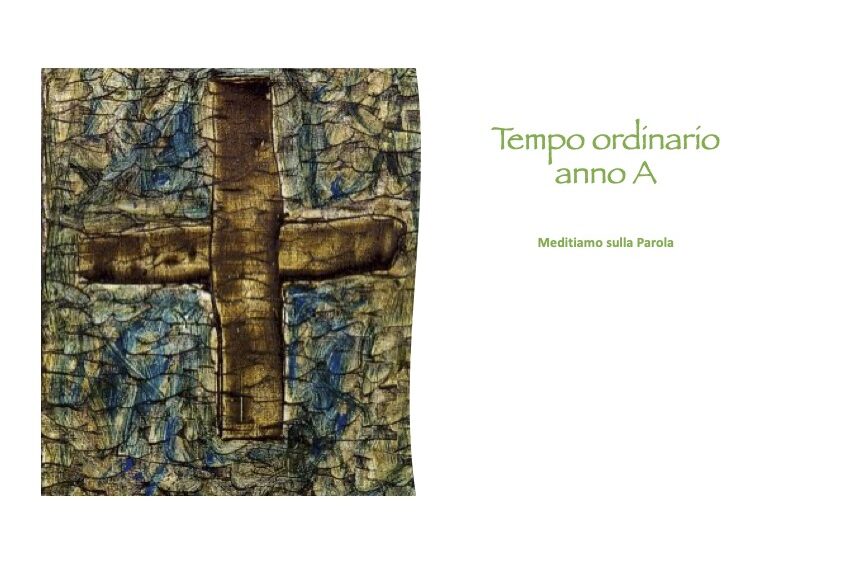
Meditiamo sulla Parola XIV Domenica tempo ordinario anno A
Il brano evangelico pone in primo piano i piccoli, coloro che sono ai margini, coloro che abitano le periferie.
Il termine “piccoli” (Anawin) nel primo Testamento, soprattutto nei libri profetici, ricorre con frequenza.
”Gli umili si rallegrino nel Signore e gioiscano nel Santo d’Israele”(Isaia 29,19).
Anawin è un gruppo particolare di Ebrei che rappresenta gli scartati di questo mondo. Sono coloro che mancano di tutto; coloro cui Dio rivolge le sue attenzioni. Confidano e si rivolgono solo a Lui.
“Gli israeliti gemono per la loro condizione di schiavi, alzano grida di lamento e il loro grido giunge a Dio” (Esodo 2,23-24). JAWEH dà inizio alla liberazione degli Ebrei dall’Egitto.
Il lamento, l’oppressione dei piccoli, non lascia indifferente Dio, perché è un Dio che ama.
Chi è il povero?
Colui che non prevarica, colui che per rimanere fedele, accetta di essere oggetto di angherie. Colui che sa che la vita è dono gratuito.
I testi sacri non demonizzano la ricchezza, ma sanno che la ricchezza costituisce un rischio (Matteo 19,24).
Il Libro dei Proverbi (30, 8-9): «Signore, non darmi né povertà né ricchezza; ma fammi avere il cibo necessario, perché una volta sazio, io non ti rinneghi e dica: “Chi è il Signore?”, oppure, ridotto all’indigenza, non rubi e profani il nome del mio Dio».
Nella Bibbia sono pressanti gli inviti a ricercare la sapienza. Chi cerca la sapienza, non si erge al di sopra degli altri, ma cura i rapporti con tutte le realtà. Il sapiente non separa il culto dalla carità.
Gesù parla a tutti anche se è consapevole che il suo messaggio richiede un’accoglienza difficile.
I piccoli sono nella condizione di vivere il vangelo alla lettera, disponibili a scelte di rinnovamento.
Non di rado si attribuisce alla pietà popolare poca importanza. Per l’uomo contemporaneo la pietà è la fedeltà a doveri ridotti ad “esercizi di pietà”. Nella Bibbia la pietà non è qualcosa di astratto, ma richiede atti, azioni che si concretizzano nelle opere.
È da notare: Luca, terminata la stesura del terzo vangelo, mette mano agli Atti/azioni degli Apostoli.
Rafael Tello, teologo argentino, fautore della teologia del popolo, fa sua la scelta preferenziale per i poveri voluta dal Concilio. Sottolinea la necessità che l’uomo non può vivere isolato.
La pietà popolare presuppone una fede che dice affidamento e fiducia in Dio. «Padre mio io mi abbandono a te, fa di me ciò che ti piace».
La salvezza non sta nei riti ma nell’amore che li anima. Gesù loda la fede della povera vedova che nel porre le monete consegna sé stessa.
La pietà popolare non può essere sottovalutata, non può essere ritenuta una Cenerentola. Bisogna ribadire senza mai stancarsi che la Parola, la Liturgia, la Catechesi, la Teologia, devono integrare gli elementi carenti. Per non cadere nel miracolismo occorre coniugare fede e ragione. Una “pietà popolare” non curata, può portare ad atteggiamenti irrazionali e anti-scientifici.
Feste popolari, confraternite, gruppi di preghiera ecc. possono essere antidoto contro il rischio di clericalismo. La “pietà popolare” è patologica se fine a sé stessa, se porta all’interno delle comunità divisioni e non comunione. È urgente un’operazione di discernimento che ama e non giudica.
Molti si sono allontananti da Gesù perché lo immaginano come uno contrario al loro desiderio di vivere liberi. Gesù costringe a leggersi dentro. Libertà non è essere generosi e disinteressati un giorno si e uno no; è facile essere schietti e leali qualche volta, è facile essere giusti a giorni alterni, o dove il rischio non è troppo alto. È facile tifare per la pace quando nessuno ci dà fastidio. Così come è facile studiare quando ne abbiamo voglia, fare sport finché non diventa molto impegnativo, coltivare l’amicizia con le persone simpatiche, interessarsi ai poveri una volta o due l’anno.
Così è facile ma non si arriva alla roccia dove poggiare la casa della propria vita, in modo da metterla al riparo da ogni tempesta e terremoto. Si alza solo polvere.