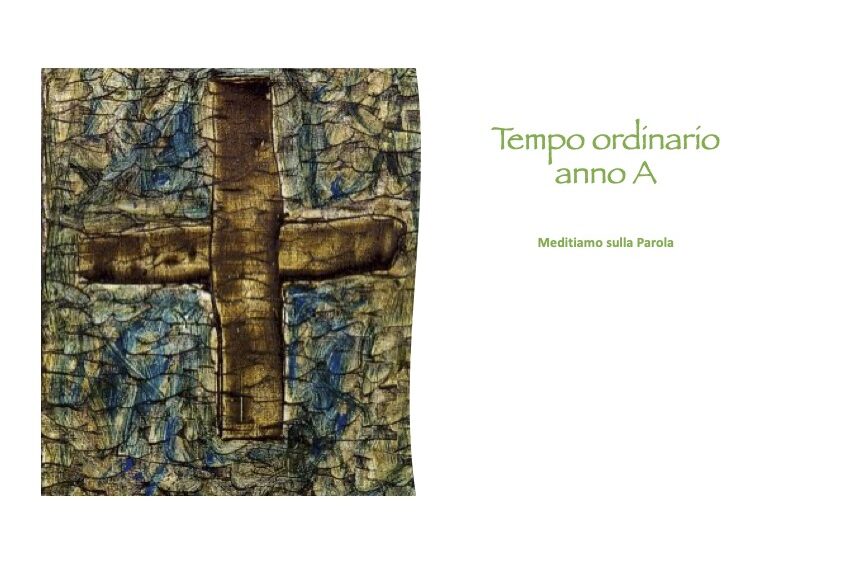
Meditiamo sulla Parola – XXVIII Domenica tempo ordinario anno A
Gesù parla in parabole per evitare un confronto/conflitto diretto. La parabola è un invito a pensare, suscita domande, invita a cambiare idea. Impara veramente chi ascolta e poi riflette, non limitandosi solo alle parole ma badando anche ai gesti. Infatti, dopo la narrazione di un evento, la parabola – in modo esplicito o implicito – si conclude con un interrogativo, che obbliga l’ascoltatore a prendere posizione. Se ciò non accade, la comprensione diventa ardua (Is 6,10ss: “Ascoltate pure ma senza comprendere, osservate pure ma senza conoscere”). Per questo, le parabole sorprendono tutti, anche chi già crede in Gesù, ma agisce in modo non conforme al Regno, che peraltro rappresenta il tema dominante delle parabole.
La parabola di questa domenica è strettamente collegata alla precedente (la parabola dei cattivi vignaioli: Mt 21,33-43); il tema di fondo è il medesimo: il rifiuto, opposto al Signore della vigna e al Re che offre il banchetto. Dopo questa parabola, Matteo riporta la domanda posta dai farisei a Gesù per metterlo in difficoltà («È lecito pagare il tributo a Cesare?»).
Una prima interpretazione della parabola può condurci a collegarla con la distruzione di Gerusalemme ad opera dei Romani nel 70 d.C. Tuttavia, questa interpretazione – benché fondata – rischia di apparire superficiale, di fatto esonerandoci dal porci gli interrogativi che essa invece intende sollevare. Il rischio, infatti, è pensare che la parabola sia indirizzata solo ai capi dei sacerdoti del popolo di Israele, mentre è rivolta a tutti noi.
Si ritiene che Gesù abbia tratto spunto da un racconto noto al suo tempo, quello di un uomo ricco, Bar Maʿjan, e di uno pio scriba, raccontata nel Talmud palestinese (“Uno non santo muore… tutti vanno al funerale. Poi muore un pio scriba… pochi vanno alla sua sepoltura. Tutti si chiedono il perché: Come può Dio essere così ingiusto da permettere una cosa simile? Il ricco, prima di morire, aveva organizzato un banchetto per i consiglieri, ma questi non andarono. Allora egli ordinò: tutti i poveri devono venire”). Gli ingredienti sono gli stessi, ma il racconto è meno bello.
Nella versione di Matteo, la parabola inizia assimilando il Regno a un banchetto di nozze, organizzato dal re per suo figlio. Mentre nelle parabole precedenti ci viene presentata la figura del padre (che invia i suoi figli nella vigna: Mt 21,28-32) e del padrone della vigna (Mt 21,33-46), qui la figura dominante è “un uomo re”. In verità, nelle versioni di Luca e di Tommaso (vangelo apocrifo), si parla solo di un uomo, a differenza di quanto accade in Matteo. Il legame con la parabola precedente emerge anche se si riflette sulla circostanza che l’erede ucciso dai cattivi vignaioli, diventa ora lo sposo (e qui si può individuare un riferimento allo sposo di sangue: Es 4,25). Il riferimento alle nozze può essere interpretato come un’immagine del rapporto tra Dio e l’uomo, un rapporto basato sulla festa, su un evento gioioso.
I servi inviati a chiamare gli invitati al banchetto sono i profeti che Dio ha inviato a Israele nel tempo, ma che spesso non sono stati ascoltati. Il secondo invio, successivo al rifiuto, può anche alludere ai missionari inviati dallo stesso Gesù. La reazione all’invito è di non-curanza: gli invitati preferiscono dedicarsi ai loro affari. Nascono, quindi, alcuni interrogativi: Come rispondiamo all’invito del Signore? Preferiamo mammona a Dio? (Mt 6,24). Il denaro, le preoccupazioni quotidiane, gli affari da sbrigare occupano tutto la nostra vita, impedendoci di partecipare al banchetto, ossia di dedicare tempo e spazio a Dio? Il cammino di libertà che Dio ci presenta è scartato a beneficio di un cammino fondato sulla schiavitù del peccato?
L’invito di Dio è pressante, non si arresta dinanzi al primo rifiuto e insiste sul carattere sovrabbondante del banchetto, un tema espresso anche nella prima lettura (Is 25,6-10) e nel salmo (32) di questa domenica.
Alla non-curanza degli invitati si aggiunge poi la reazione violenta e aggressiva di alcuni (“i rimanenti, presi i suoi servi, li oltraggiarono e uccisero”). Sembra, qui, esserci un riferimento ai capi dei sacerdoti e ai religiosi, ai quali Gesù indirizza la parabola per evitare uno scontro diretto con loro. La reazione dura del re, che invia i suoi servi a incendiare la città degli assassini, va letta come ammonimento e, come già evidenziato, non deve esonerarci dal rispondere agli interrogativi sollevati dalla parabola.
Il racconto potrebbe terminare qui, Invece, notiamo che riparte con un nuovo invio dei servi. I primi invitati non erano degni (Ap 3,17: “Tu dici: «sono ricco, mi sono arricchito, non ho bisogno di nulla»; ma non sai di essere un infelice, un miserabile, un povero, cieco e nudo”), per cui i servi escono per invitare tutti quelli che trovano per le strade (nella versione di Lc 14,21: poveri, storpi, ciechi e zoppi, ossia gli emarginati, gli ultimi). La festa non è sospesa, il Re non si ferma dinanzi ai rifiuti ma va avanti ed estende a tutti l’invito, il che significa che la misura di Dio è sovrabbondante (v. salmo 32). È da notare che non è applicato alcun filtro: sono invitati “malvagi e buoni” (v. parabola del grano e della zizzania; Mt 13,24-43). La festa non è interrotta, riparte con un nuovo inizio e il rifiuto dei primi diventa occasione per un’apertura universale: tutti sono invitati, senza distinzione alcuna (At 1,8: «…avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni… fino agli estremi confini della terra»). La sala del banchetto finalmente si riempie.
A questo punto, la parabola potrebbe terminare, ma osserviamo una terza ripartenza: il re entra nella sala per salutare i commensali e nota uno senza la veste. Razionalmente, potremmo osservare che costui, essendo stato invitato mentre era per strada, potrebbe non aver avuto la possibilità di indossare l’abito adatto per la festa. In verità, dobbiamo tener presente che a quel tempo chi organizzava un banchetto donava gratuitamente un abito ai commensali. Pertanto, la persona senza veste ha rifiutato questo (ulteriore) dono gratuito. Il messaggio per noi è chiaro: entrare nella sala del banchetto non è sinonimo di salvezza. Il Regno è una realtà dinamica, non statica: l’amore di Dio si configura quale permanente ri-creazione. L’adesione al banchetto diventa quindi occasione per un cambiamento di stile di vita, da intendere non come una condanna, ma come evento gioioso: il credente è una persona liberata dalla schiavitù del peccato e la vita cristiana è una gioia che non è evasione ma è una forza e una sfida, sottintendendo un invito alla responsabilità. Non ci attende una resa dei conti, bensì un banchetto con “vini eccellenti e cibi succulenti” (Is 25,6).