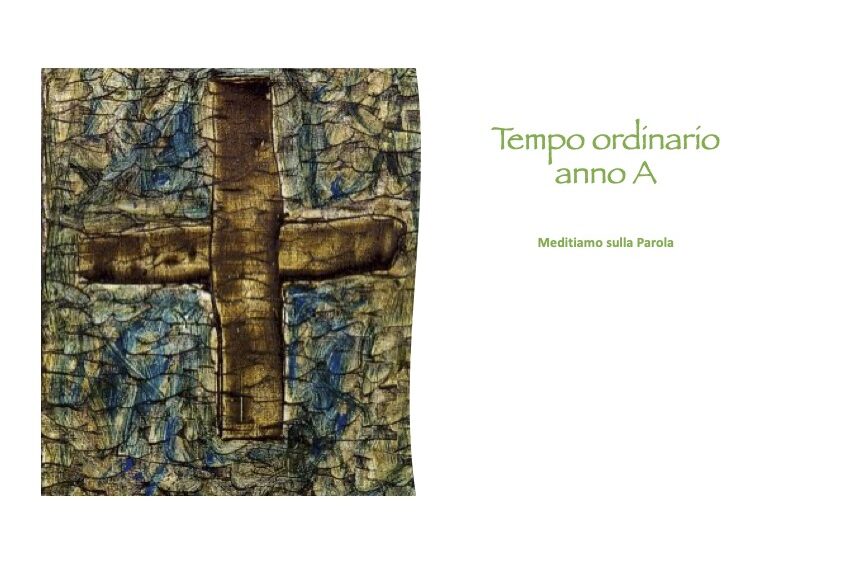
Meditiamo sulla Parola – XXIX Domenica tempo ordinario anno A
Il brano del vangelo della XXIX domenica (Mt 22,15-21), come quelli delle domeniche successive, riporta quattro controversie sorte tra Gesù e i rappresentanti dei vari gruppi religiosi dell’epoca. Controversie che avvengono nel tempio di Gerusalemme in prossimità della sua passione e morte. Questa volta sono i farisei che tentano di mettere Gesù in contraddizione con la sua fede e la sua predicazione. Per questo gli inviano dei loro discepoli, insieme a dei partigiani di Erode. Entrambi i gruppi volevano l’instaurazione di un regno teocratico in Israele: i farisei attraverso il dominio della loro legge e del re Messia, gli erodiani attraverso l’estensione del regno di Erode a tutta la terra santa, in autonomia dall’impero romano. Quindi per gli erodiani il pagamento del tributo non costituiva problema, gli zeloti erano contrari e i farisei pagavano rassegnati questa tassa per evitare il peggio. L’intenzione dei farisei è di intrappolare Gesù e quindi con furbizia gli fanno una domanda che, qualunque sia la risposta, lo lascerà senza via dia di scampo; ciò che a loro interessa non è la verità ma cercare di incastrarlo.
“Maestro sappiamo che sei veritiero ed insegni la via di Dio secondo verità”. È il più bel complimento fatto a Gesù, ma nelle loro intenzioni c’è semplicemente quella di indurre Gesù a dichiararsi idolatra di Cesare o contestatore di Cesare, così la sua colpa sarà evidente in un caso agli occhi dell’autorità religiosa ebraica e, nell’altro a quelli dell’autorità politica romana.
“Dicci dunque che te ne pare è lecito pagare il tributo a Cesare?” Questo tributo o censo era dovuto da ogni suddito, esclusi bambini e vecchi, agli occupanti romani. Ma Gesù avendo compreso la loro malizia (spregiudicatezza e compiaciuta consapevolezza a compiere il male) risponde: “Perché mi mettete alla prova ipocriti?” L’ipocrisia sarà il ritornello del cap.23, dedicato a chi si serve della verità, invece di servirla.
E risponde alla domanda facendosi portare una moneta e rivolge loro questa domanda: “Di chi sono questa immagine e l’iscrizione?” L’iscrizione sulla moneta dice “Tiberio Cesare figlio del Dio Augusto” con l’immagine dell’imperatore. A questo punto non può esimersi dal rispondere, se afferma che è lecito pagare il tributo si mostra a favore di Cesare, anzi idolatra dell’impero totalitario e, così il popolo che attendeva il Messia liberatore dal giogo romano lo sentirebbe come un traditore. Se al contrario, rispondesse negativamente, allora gli erodiani avrebbero motivo per denunciarlo come un pericoloso agitatore sociale anti-romano Al sentirsi rispondere di Cesare può concludere con una sentenza celebre “Restituite a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” queste parole sono come una chiave da decodificare, inoltre occorre molta vigilanza per non renderle uno slogan, come tante volte è successo e succede nei rapporti tra stato e chiesa, tra l’autorità politica e cristiani.
Che cosa significa quindi questa frase? È vero che secondo le Scritture, il potere esercitato sulla terra viene da Dio, anche Ciro, nella prima lettura era un “unto”, un messia di Dio, il quale pur senza conoscere il Dio di Israele e senza credere in lui, aveva compiuto azioni volute da Dio stesso, diventando suo strumento. Nel Secondo Testamento, l’Apostolo Paolo applica la medesima convinzione alla situazione dei cristiani nell’impero: occorre prestare obbedienza leale alle autorità dello Stato (cf Rm 13,1-7; Tt 3,1-2). Che cosa significa questo? Che lo Stato, l’autorità politica è necessaria alla vita della polis e dei credenti in essa. La città abitata dagli uomini e dalle donne abbisogna di ordine, legalità, giustizia e dunque non si può vivere in una società senza un’autorità cui rispondere lealmente. Quindi il cristiano non può essere un anarchico che si schiera contro lo stato, contro l’autorità politica, ma qui ecco apparire lo specifico della via aperta da Gesù Cristo, dunque dal cristianesimo, che può anche sembrare paradossale: il cristiano obbediente alle leggi dello Stato deve riconoscere sempre “ciò che è di Dio” e cos’è di Dio? La persona umana, l’uomo non Cesare è immagine di Dio. Quindi il potere nella polis è riconosciuto, ma non in modo assoluto, senza limiti, va obbedito finché non schiacci, non opprima la persona nella sua libertà, dignità, nella sua coscienza. Il potere politico concepito in modo teocratico, viene da Gesù desacralizzato. Quella del potere di Cesare è una funzione necessaria, ma umana, esercitata da esseri umani. E di fronte a Cesare sta il diritto di Dio, del Signore, che è garante di tutta la grandezza e la libertà dell’essere umano. A Cesare quindi va pagato il tributo che deriva dal suo potere, ma ciò che appartiene a Dio, la vita umana, va data a Dio.