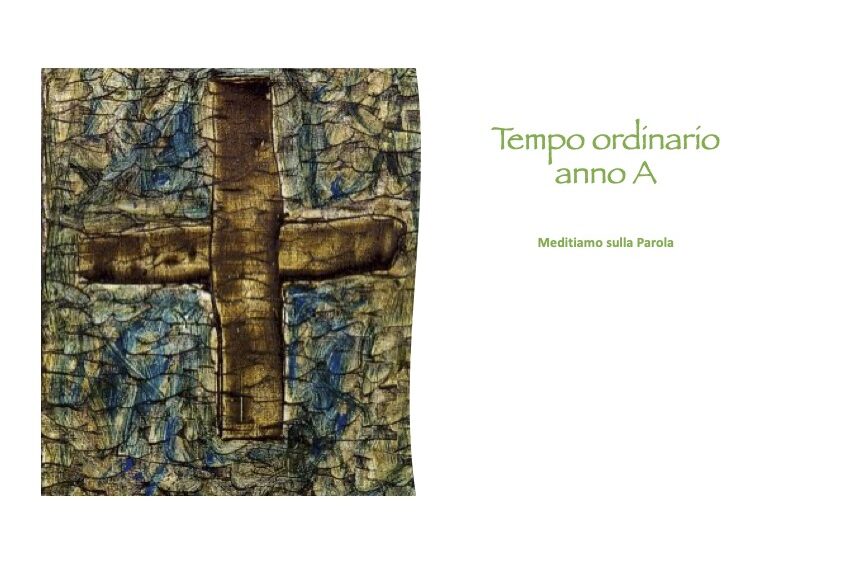
Meditiamo sulla Parola – XXX Domenica tempo ordinario anno A
Raggiunta Gerusalemme per l’ultima stagione della sua vita, Gesù è presentato dall’evangelista in un acceso dibattito con i teologi e con i rappresentanti del giudaismo ufficiale di allora ossia farisei, sadducei, sacerdoti, dottori della legge e scribi. Si nota, con immediatezza, la differenza con il testo di Marco. Matteo priva la discussione del colorito umanissimo che assume in Marco: l’incontro tra due persone sinceramente volte alla ricerca del regno di Dio.
Se in Marco, infatti, il Signore è avvicinato da uno degli scribi con il quale si instaura fin da subito un’intesa cordiale, un’autentica ricerca del regno di Dio, in Matteo, invece, i farisei si radunano quasi per uno scontro frontale. Uno di questi prende la parola per metterlo alla prova.
La sostanza della discussione è identica: alla domanda circa il grande precetto (espressione più vicina al testo ebraico kelal gadol) Gesù risponde rimandando al Comando dello Shema’. Tuttavia, tutto ciò che segue in Marco ossia l’approvazione dello scriba e l’incoraggiamento rivolto dal Signore al dottore della legge viene omesso in Matteo.
La domanda è pertinente poiché nel giudaismo ebraico, la Legge aveva assunto un posto di rilievo nella rivelazione scritta: i primi cinque libri biblici erano i più studiati e i più meditati, avevano un primato rispetto agli altri ossia i libri dei sapienti e dei profeti.
Nello studio della Torah i dottori della legge, con l’innato desiderio tipico del giurista e del sapiente orientale avevano enucleato oltre alle dieci parole date da Dio a Mosè ben 613 precetti come spiega un testo della tradizione ebraica: Rabbi Simlaj disse: “Sul monte Sinai a Mosè sono stati enunciati 613 comandamenti: 365 quanti i giorni dell’anno erano divieti, e 248 quante le membra del corpo umano erano ingiunzioni positive. Poi venne David, che ridusse questi comandamenti a 11, come sta scritto nel Sal 15, 2-5 “Chi entrerà nella dimora del signore: colui che cammina senza colpa/ agisce con giustizia/parla lealmente/ non dice calunnia con la lingua/ non fa danno al suo prossimo/ non dà insulto al suo vicino/ disprezza il malvagio/ onora gli amici del Signore/ non cambia anche se giura a suo danno/ non presta denaro con interesse/ non accetta doni contro l’innocente” Poi venne Isaia che li ridusse a 6, come sta scritto di colui che potrà abitare presso un fuoco divoratore se “cammina nella giustizia/ parla con lealtà/ rigetta il guadagno frutto dell’oppressione/ si tura le orecchie per non udire fatti di sangue/ chiude gli occhi per non essere attratto dal male” Poi venne Michea che li ridusse a 3, come sta scritto: “ciò che richiede all’uomo il Signore: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare con umiltà” (Mi 6,8) Poi Amos li ridusse a 2, come sta scritto: “Cercate me e vivrete” Infine venne Abacuc e li ridusse a uno solo, come sta scritto: “Il giusto per fede vivrà “ (Ab 2,4; cf. Rm 1,17; Gal3,11)” (Talmud babilonese, Makkot 24a).
La gerarchia di valore e di importanza di tali precetti era spesso oggetto di pedanti discussioni tra i dottori della legge, i quali cercavano di definirne, per rilievo la sequenza esatta.
Gesù sembra voler accordarsi a tale impostazione offrendo la sua ipotesi di soluzione con i due comandamenti: “Amerai il Signore tuo Dio e Amerai il prossimo tuo come te stesso” ponendoli come primari della lista dei precetti. In realtà Egli scardina ogni forma di legalismo. Gesù non innova rispetto al Primo Testamento, ma si mostra autorevole ermeneuta della volontà del Padre. Il Signore va al fondamento della vita del credente con lo Shemà Jisra’el, che veniva ripetuto tre volte al giorno: “Ascolta Israele, il Signore è tuo Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il tuo Dio con tutto it tuo cuore, con tutta la tua mente con tutta la tua forza” (Dt. 6, 4-5) ma, al contempo va oltre, accostando all’amore per Dio, l’amore per il prossimo.
La dimensione verticale (amore per Dio) e quella orizzontale (amore per il prossimo), dunque si incrociano e si vivificano reciprocamente costruendo “l’essere cristiano” totale e genuino.
L’amore per Dio e per il prossimo è l’architrave, l’anima, la chiave di volta di “tutta la Legge e di tutti i profeti”.
Nella risposta di Gesù al dottore della legge, secondo il testo greco risuona per due volte il verbo agapàn, “amare”, il cui sostantivo agàpe, amore, è entrato nel linguaggio comune cristiano.
Nel 1930 uno studioso svedese Anders Nygren ha pubblicato un rilevante studio sulla contrapposizione tra le due visioni dell’amore: l’eros, inteso come contemplazione estetica, conquista, possesso, e agàpe definito come donazione, dedizione, generosità illimitata, senza ricompensa.
Il tema dell’agàpe è, dunque, fondamentale, ed è riportato nelle Scritture attraverso i tre modelli classici dell’amore nuziale (Osea, la cui drammatica vicenda matrimoniale diventa l’emblema dell’amore divino che vince i tradimenti, supera i deserti, e anela a risorgere oltre il suo fallimento); l’amore materno (Isaia 49, 15 “Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero io invece non lo dimenticherò mai”); l’amore paterno (ancora Osea 11, 1.4 “Quando Israele era giovinetto io l’ho amato… Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare”).
Un amore nuziale, materno e paterno che si schiude nel silenzio dell’essere e ci fa esistere, sboccia nella tenebra del nostro peccato e ci salva; “Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ci ha amati per primo.” L’amore è reciproco e Dio attende la nostra risposta. È per questo che il ritornello “Dio ama il suo popolo”, si trasforma nel costante appello della Bibbia “Ama il Signore, con tutto il cuore, l’anima e le forze”.
Quali sono, invece, i tratti dell’amore fraterno? L’amore fraterno può essere delineato attraverso tre caratteri essenziali:
- universale (Primo e Secondo Testamento: “Il forestiero dimorante tra voi lo tratterete come colui che è nato tra voi. Tu l’amerai come te stesso” (Lv. 19,34) “Io vi dico Amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori” (Mt. 5,44);
- totale, radicale, supremo. Gesù nei discorsi di addio riferiti a Giovanni tenta di rendere ancor più radicale il parallelo suggerito dall’appello che oggi ci è indirizzato. All’”amare il prossimo come te stesso” egli sostituirà un “amare il prossimo come io vi ho amati”;
- infinito, assoluto, che non risparmia se stessi e la propria vita, reciproco, “Amatevi gli uni gli altri” Gv 13, 34; 15,12. 17.
I due piani dell’amore divino e dell’amore umano non sono indipendenti e staccati; si intersecano diventando una grandiosa e luminosa croce che, piantata nella terra, ha il vertice in cielo e ha i bracci che raccolgono il mondo intero.
Giovanni 4,20-21 nella sua prima lettera dice: “Se uno dicesse: Io amo Dio e odiasse il suo fratello, è mentitore. Chi infatti non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede. Questo è il comandamento che abbiamo da lui: Chi ama Dio ami anche suo fratello”.