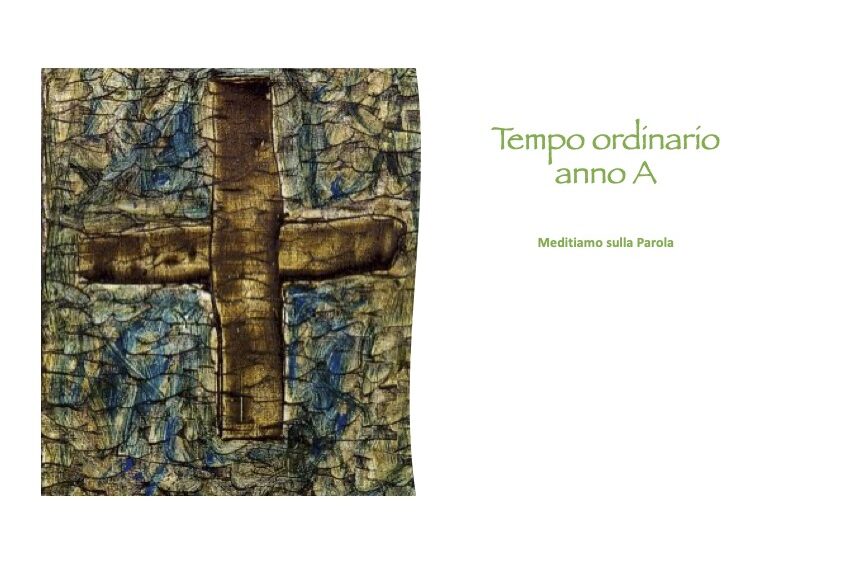
Meditiamo sulla Parola – XXXI Domenica tempo ordinario anno A
Il cap. 23 di Matteo è un unico discorso di Gesù, discorso molto severo, qualcuno dice addirittura il più duro dell’intero vangelo; è incastonato fra il cap. 22 (dove troviamo la parabola del banchetto nuziale, il quesito sul tributo a Cesare, la risurrezione dei morti, il comandamento più grande, Cristo quale figlio di Davide e Signore) e il cap. 24 (predizione del destino e delle tribolazioni di Gerusalemme, l’avvento del Figlio dell’uomo, le parabole del fico e del servo buono e del servo cattivo, della necessità di vegliare).
Viene di solito suddiviso in 3 parti: 1-12 critica allo stile di vita di scribi e farisei; 13-36 sette invettive (GUAI, in ebraico OUAI quasi simile, A VOI) contro gli stessi; 37-39 il dolore di Gesù per Gerusalemme, con una splendida similitudine (la chioccia che raccoglie i pulcini sotto le proprie ali) che sottende e svela tutto l’amore tenero e dolcissimo per l’umanità. Il capitolo termina con la profezia sulla propria sorte e l’incapacità del popolo di riconoscerlo come il Messia.
Gesù è dunque a Gerusalemme, molto probabilmente al tempio o nei pressi, vede passare scribi e farisei e non si trattiene, non tace, firmando così la propria condanna a morte; verrà infatti processato e crocifisso per tanti motivi (politici, sociali ecc.) ma soprattutto per le critiche puntuali e circostanziate alla struttura sacerdotale che ha modificato, annacquato o esasperato, adulterato nella sostanza più intima la parola di Dio a proprio esclusivo vantaggio. Gesù è chiarissimo: quando predicano dicono, in genere, cose anche accettabili, ma il loro esempio è pessimo, fuorviante, letteralmente scandaloso, cioè di inciampo, per i più piccoli nella fede.
Guardiamoli allora questi personaggi con gli occhi di Gesù, tutto in loro concorre a marcare la distanza col popolo, con i poveri e i semplici, per poter meglio risaltare come i migliori, i sapienti, gli illuminati e puri. Dice Gesù: “Si sono seduti sulla cattedra di Mosè” ma, in realtà, Mosè tutt’al più ci viene descritto come seduto su una scomoda pietra del deserto e comunque mai per esercitare un potere, piuttosto per obbedire e proteggere il popolo di Dio, magari con enfasi, magari con durezza. Invece gli altri si sono accomodati per esercitare un dominio e un controllo, dimenticando che il dono più grande del Creatore alla creatura è la libertà, quella che Dio stesso ha rispettato e rispetta a rischio, secondo alcuni teologi, di dover addirittura autolimitare e contrarre, per amore, la sua stessa onnipotenza.
E l’aspetto esteriore? Presto detto: un continuo riferimento ai testi biblici, per auto-accreditarsi presso le folle, spuntano i filatteri (in ebraico TEFILLIM) indossati secondo quando raccomandato in Deuteronomio (6,8) e si allungano le frange dei mantelli (in ebraico rispettivamente TZITZIT e TALLET), prescritte nel libro dei Numeri (15, 38-41). E queste frange, promemoria, memoriale nei secoli, sono diventate sempre più lunghe e visibili perché scorgendole tutti potessero riconoscere e lodare la loro adesione al testo sacro e la loro obbedienza alla Torah. In realtà i sacerdoti avevano bisogno di vesti e simboli esteriori per affermare in qualche modo la loro autorità, questa parola viene dal latino e significa “far crescere, riempire”, ma va intesa come “far crescere l’altro” non sé stessi, Quindi questi personaggi privi di autorità morale se ne auto-attribuiscono una esteriore con frange e scatolette rituali.
Rabbì bisognava chiamarli, dice Gesù, che invece voleva essere chiamato amico, anzi qualche capitolo più avanti si chinerà addirittura nel gesto dello schiavo che lava i piedi al padrone ed insegnerà, nell’urgenza della morte sempre più vicina, che solo come fratelli, tutti insieme, è possibile costruire il Regno di Dio, nello sforzo quotidiano di servire l’altro, amando finanche la puzza dei loro piedi (o come dice papa Francesco: facendo i pastori con addosso l’odore delle pecore).
Al versetto 27 del nostro capitolo, infine, la condanna definitiva: Gesù li chiama sepolcri imbiancati col fetore della morte a svergognarli in maniera categorica; a tal proposito, ricordiamo che secondo la cultura ebraica ortodossa (di quel tempo e non solo), tutto ciò che riguardava i morti, i cadaveri, la decomposizione, addirittura la semplice vista, era estremamente repellente ed anti-cultuale. Basti pensare alla fretta nel rimuovere i corpi di Gesù e degli altri condannati prima che, dopo il tramonto, cominciasse un sabato solenne. Chiamarli dunque “sepolcri imbiancati” era un’offesa al limite della blasfemia.
E infine, viene prima nel testo ma è stata lasciata di proposito per ultimo, potendo essere considerata la colpa più grave contro cui per i piccoli, i semplici non c’è scampo o via di fuga. Ricordate? Dio ha dettato a Mosè solo 10 “parole”- comandamenti, ma nei secoli la struttura religiosa ha portato a ben 613, i MITZVO’T (i precetti obbligatori); di questi, 248 sono obblighi e 365 divieti e i bravi scribi, farisei e sacerdoti, che insieme con Gesù stiamo vedendo passare, sono puntuali e precisi nel ricordare tutto ciò al popolo, caricando sulle loro spalle l’enorme masso delle norme rigide e spesso immotivate, guardandosi bene, non solo dall’attuarli nella propria vita, ma addirittura dallo sfiorare lo spropositato numero di regole e regolette che non avrebbero liberato, accompagnato, indirizzato l’uomo, come era nel progetto divino, dove le norme sono un aiuto, un’indicazione, una specie di segnale stradale.
Sotto un tale peso, qualunque credente è sempre in fallo, sbagliato, inadeguato. Tutto questo insieme di precetti e norme aveva dunque lo scopo non di mettere in piedi l’essere umano (come invece Gesù fa tante e tante volte dicendo sempre “Alzati!” quando cura, guarisce, risana anima e corpo di chi incontra, perché la dignità della creatura amata pretende la stazione eretta). L’obiettivo era di prostrare, far sentire inadeguati, sempre in colpa, sempre sbagliati. Sostanzialmente lo scopo è di legare il fedele affinché stia buono e zitto. Eppure, la Genesi ci dice che Dio guardando l’opera della creazione e soprattutto la sua creatura vede che è “COSA BUONA”: perché dunque umiliarla così?
Gesù semplifica tutto: uno o forse due comandamenti, il secondo diretta conseguenza del primo che è imprescindibile e inderogabile, in sintesi, il tutto in 10 parole: AMA DIO-AMA TE STESSO E COSÌ AMA IL PROSSIMO.
Come poteva non essere avversato un tale contestatore rivoluzionario? Come può il potere costituito, politico o religioso, di ogni tempo (anche quello attuale) che non ama il popolo, le creature e il disegno di Dio e ricerca invece la stabilità e la comodità di norme apparenti, come può non perseguitare, ostacolare, far sentire estraneo chiunque la pensi in modo diverso, qualcuno che organizzi la propria vita in modo aderente al messaggio vero, intrinseco dei Vangeli?
Tutto ciò detto, stiamo ben attenti a non sbagliare anche noi: Enzo Bianchi invita a riflettere e a ripensare tre punti:
1) Gesù si riferisce alla classe sacerdotale del suo tempo a Gerusalemme, non condanna tutti gli scribi e tutti i farisei in quanto tali. I Vangeli presentano figure di farisei e scribi di tutto rispetto. Qualcuno Gesù lo ha voluto con sé durante l’avventura della sua vita pubblica, qualcun altro (PAOLO) è divenuto il teorico e il sistematore della dottrina cristiana, farisei e scribi che hanno saputo ascoltare e compiere una metanoia, un cambiamento, una conversione a “U”.
2) Il suo richiamo si applica benissimo a sacerdoti di ogni tempo, di ogni luogo, di ogni cultura che adottino comportamenti analoghi.
3) Il discorso va allargato a tutti coloro che si dicono credenti, di qualsivoglia fede; siamo fragili e deboli tutti, lo sappiamo bene; quindi, il problema non è non commettere azioni diverse da ciò che si proclama (è accaduto, accade e accadrà a ciascuno di noi), l’errore è non riconoscerlo prima con noi stessi e poi con gli altri, mentendo a noi stessi e a loro sulla nostra presunta integrità e santità. Insomma, tutti siamo obbligati a “non fare narrazioni sempre positive di sè e delle proprie azioni… lasciando così ad altri la possibilità di giudicare la falsità o la verità.”
Gesù termina e riassume: “Uno solo è il vostro maestro (didaskalos)… uno sola è la vostra guida (kateghetes)… uno solo è il padre (pater)”. A noi il compito di ricordare che qualsiasi precetto, qualsiasi istituzione religiosa, ”se si trasforma da mezzo a fine, diventa un fattore di asservimento, diventa ideologia non è più a servizio della vita e dell’amore”. Paolo nella lettera ai Galati (5,1-13;14) dice: “Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà…; mediante l’amore siate a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso”.