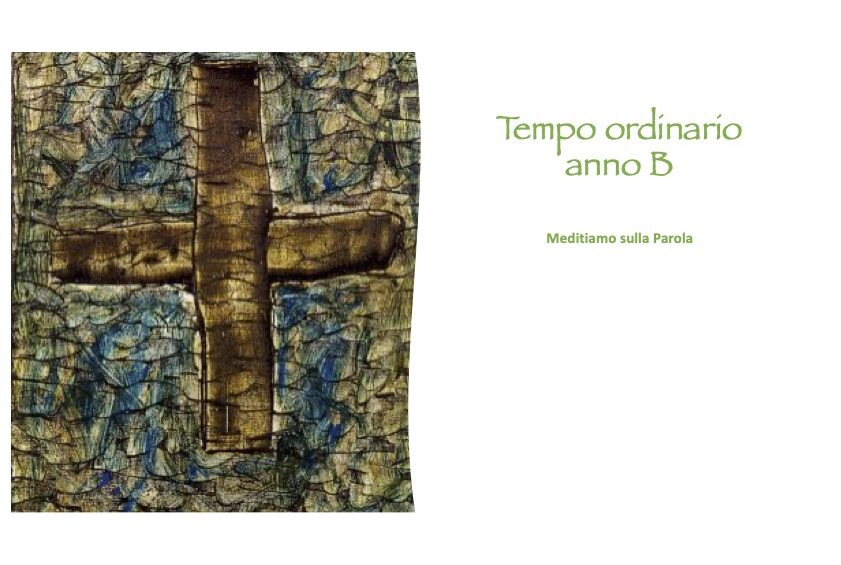
Meditiamo sulla Parola – V Domenica tempo ordinario anno B
Il brano della prima lettura costituisce la risposta di Giobbe, all’intervento del primo dei suoi amici Elifaz. Elifaz valida la tesi teologica tradizionale della retribuzione terrena: i mali che affliggono Giobbe non si possono spiegare se non come punizione di gravi peccati. Se Dio affligge coloro che parevano giusti è per loro far espiare peccati di omissione o colpe inavvertite o per far prevenire colpe più gravi.
A questa rigida correlazione, Giobbe reagisce con veemenza, contesta le scontate formule della teologia della tradizione, “ distrugge la religione” ribadendo la sua innocenza e riconoscendosi nel comune destino che colpisce l’intera umanità. “Ricordati che un soffio è la mia vita”: Giobbe descrive con intensità la sua situazione di dolore, avverte l’imminenza della sua fine e fa un appello a Dio perché si mostri quale Dio della vita.
Egli esordisce con alcune metafore che ben rappresentano la fugacità e lo scorrere della vita terrena. La prima è quella universale del tessitore e della spola. “Come la tenda dei pastori, come un tessitore, hai arrotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama.” (Is 38, 12). La seconda del bracciante, soldato/mercenario, schiavo sottolinea la condizione di duro servizio obbligatorio, di dipendenza dell’uomo che, come un salariato, aspira al riposo e ad una retribuzione. “A Giobbe, uomo di pena non basta un’illusione per farsi coraggio” (G. Ungaretti). Il problema di Giobbe è quello di trovare un senso alla sua vita. Per il credente il senso c’è: chinare il capo e affidarsi alle vie imperscrutabili di Dio non dubitando di un disegno che rimane ingarbugliato sulla terra ma verrà svelato in tutta la sua bellezza ed armonia quando vedremo Dio faccia a faccia. “Il dolore per il credente e il non credente è una porta: aprendola puoi trovare Dio o il diavolo, la vita o la disperazione.” (K. Barth).
Il libro di Giobbe introduce il Vangelo. La giornata di Gesù è scandita in tre tempi. Il primo si svolge a casa di Simone Pietro con la guarigione della suocera; il secondo, la sera dopo il sabato, s’impernia sulla lotta acerrima del Signore contro le forze del male ed il terzo, l’indomani al mattino con la decisione del Messia di andare altrove.
Gesù guarisce la suocera di Pietro. L’inizio del brano è scandito dall’avverbio subito che conferisce imminenza all’azione. L’azione di Gesù avviene nel silenzio. Egli si avvicina e la fa alzare prendendola per mano, il gesto è di una tenerezza unica e comunica la forza della sua vita alla persona e la rialza.
Il verbo servire (diakonèo) e il termine servitore (diàkonos) denotano un servizio fatto per amore, affetto e adesione a Gesù e caratterizzano un servire che viene fatto all’interno della comunità. Per indicare il servizio fatto agli altri specialmente ai pagani, viene impiegato il termine servo (dùlos).
Nella seconda scena di guarigione Marco fa delle precisazioni preziose: Venuta la sera, dopo il tramonto del sole gli portavano tutti i malati e gli indemoniati.La novità in questo secondo quadro terapeutico è la folla dell’intera Cafarnao che si raduna davanti alla casa portando gli ammalati. Questo gruppo indefinito che porte gli ammalati a Gesù è significativo favorisce l’identificazione dei lettori nella solidarietà silenziosa nei confronti di coloro che sono ammalati nel corpo e nello spirito. Le guarigioni rivelano il farsi prossimo di Dio ad ogni umano soffrire, il suo impegno ed amicizia per gli squalificati dalla vita.Agli uomini feriti nella loro salute, oppressi dalla sofferenza Gesù non predica rassegnazione, non chiede di offrire la sofferenza a Dio, né d’altra parte incoraggia atteggiamenti di ricerca del miracolo. Il Signore compie gesti di comunione, incontra i malati non teme di avvicinarli e toccarli si piega sui corpi per curarli, lotta contro il male per farlo arretrare.
Nella terza ed ultima. Gesù esce al mattino molto prima dell’alba e va fuori dalla città in luogo deserto per pregare. E’ la prima volta che nel Vangelo di Marco si parla della preghiera. L’atteggiamento orante indica la relazione autentica con il Padre. In Marco il pregare del Figlio scandisce i momenti di passaggio della sua vita e della sua missione. La preghiera indica con la decisione che il Signore comunica con fermezza ai discepoli, Andiamocene altrove, nei villaggi vicini perché io predichi anche là per questo infatti sono venuto.
La preghiera è all’origine della missione, espressione del suo libero amore per portare il Vangelo di Dio.