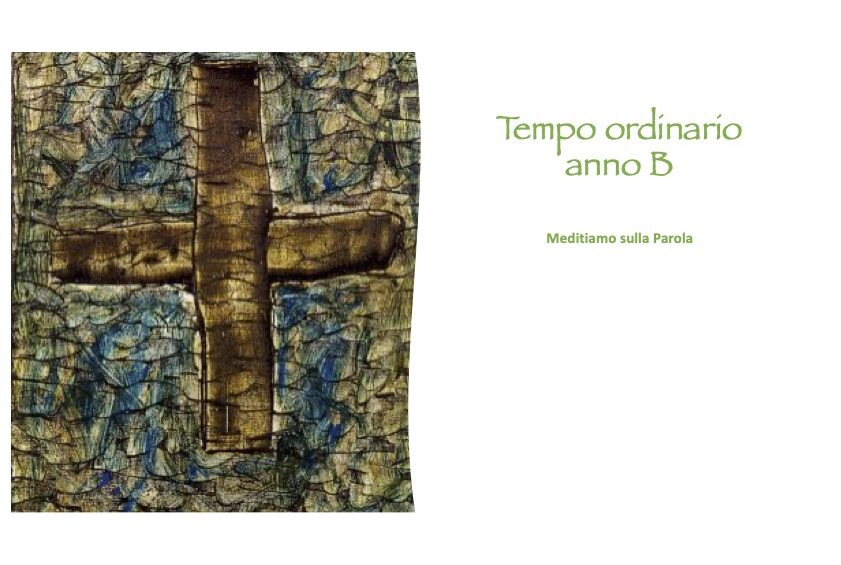
Meditiamo sulla Parola – VI domenica del tempo ordinario anno B
(L.v 13,1.45-46; 1Co 10,31-11,1; Mc 1,4-45)
Il brano di Marco, semplice e comprensibile a livello formale, presenta uno dei tanti miracoli di Gesù ed è ricchissima di rimandi al libro del Levitico da cui è tratta la prima lettura della liturgia odierna.
In questa pagina il lebbroso non chiede di guarire (questa parola non compare mai) ma di essere purificato, Gesù lo tocca ”ed egli fu purificato”. Forte appare, dunque il contrasto fra PURO e IMPURO, immagine presso il popolo di Israele, e non solo, di un formalismo superficiale che giudica impuro, malato, lebbroso, emarginabile chiunque si mostri diverso rispetto ad uno standard comune, omologato, controllabile.
Il lebbroso per gli ebrei è quasi invisibile, deve essere “velato fino al labbro superiore”, addirittura considerato un morto, ma “questo” lebbroso non ci sta ad essere considerato un pezzo fallato, una rotellina sbagliata dell’ingranaggio, un trasgressore, perciò grida e non per avvertire gli altri come da norma, grida per richiamare l’attenzione su di sé e non solo, si avvicina, elimina la distanza prescritta, viola la norma, provoca Gesù (Hai detto che sei venuto per i malati? Eccomi, in ginocchio, ma eccomi).
Le parole del lebbroso sono “Se vuoi…” e questo è teologicamente rilevante: tutto viene messo nelle mani e nella volontà del Dio fatto uomo, questa e solo questa, lo diciamo anche per noi, oggi, è la giusta postura mentale di chi crede veramente: solo Dio può, perché tutto è dono per l’uomo dal suo primo al suo ultimo respiro, nulla deve fare l’uomo per ottenere il bene, in realtà nulla può essere fatto dall’uomo per ottenerlo. Sola è richiesto la disponibilità ad accettare il dono.
Gesù reagisce a suo modo, alcuni codici hanno nel versetto 41 un verbo che indica un moto di compassione viscerale altri, come il codice Vaticano, riportano una reazione quasi rabbiosa, sicuramente molto accesa, con un verbo che origina dalla parola greca che indica la collera. La questione non è di secondaria importanza perché ci dice, qui ed altrove nei Vangeli, che Gesù, di fronte alla sofferenza fisica e morale dell’uomo, ha una reazione violenta contro il dolore di tutte le creature malate nel corpo e nell’anima.
In Gesù il movente della guarigione non è la compassione, ma il più ampio contesto della sua volontà di lottare contro tutto quello che è contrario al disegno originario del Padre. Quindi non la COMPASSIONE del testo impropriamente tradotto, ma la violenta ribellione al male, per cui si avvicina a sua volta, trasgredisce a sua volta, tocca chi era costretto ad autodefinirsi impuro, un gesto quello di Gesù che secondo la norma lo rende impuro a sua volta, caricandolo di tutte le colpe e le limitazioni dell’altro, un incontro di due trasgressioni.
Come ho già detto queste riflessioni valgono per il lebbroso, ma per estensione ai nostri giorni, anche per chi è solo, emarginato, povero o “diverso”, come si usa dire (diverso da chi?), noi invece crediamo che la “pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo” (Mt 21) e così Gesù guarisce il singolo e la comunità restituendole un membro importante come dovrebbe essere ogni uomo sulla terra.
Avvenuta la guarigione, e siamo al versetto 43, segue una frase con parole ancora molto forti “ammonendolo severamente” e “lo scacciò” (in greco quasi LO GETTÒ VIA) e gli dice di non parlarne con nessuno, ma non dobbiamo meravigliarci, queste espressioni potenti indicano la volontà del Messia di fare tutto secondo la volontà del Padre, egli rifugge continuamente dalla fama che gli viene dai miracoli, non vuole assolutamente sfruttare la malattia e le sofferenze dell’uomo per farne “marketing evangelico”, vuole una fede libera, non condizionata neppure dalla riconoscenza, non intende dare neppure la più lontana impressione di soggiacere alla tentazione del Divisore che all’inizio della vita pubblica gli suggerì di gettarsi dal pinnacolo del tempio per accreditarsi presso gli uomini, Gesù lo liquidò con “Non tentare il Signore Dio tuo” e che si ripresenterà sul Calvario nelle parole di chi lo deride : “Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto”(secondo Luca ) oppure: “Se è il re d’Israele, scenda ora giù dalla croce e noi crederemo in lui.” (secondo Matteo), come se la fede potesse essere sottoposta a condizioni.
Fr. Luigi della Comunità di Bose acutamente fa notare che: “L’uomo (il lebbroso) ha fatto appello alla volontà di Gesù per essere purificato, ed è riuscito a far breccia nel suo cuore, ma di quella sua volontà, di quali travagli il Messia attraversi nella ricerca di una conformità alla volontà del Padre, egli sa ben poco…”
Ormai purificato invece di obbedire alla parola di Gesù, se ne va in giro “proclamando e divulgando il fatto” (lett. “la parola”). Verrebbe da dire: si è lasciato prendere dall’entusiasmo! Ma chiediamoci: bisogna rallegrarsi o no di questa sua reazione? Sembra difficile sfuggire all’impressione che un cammino di rinascita iniziato bene sia stato deviato verso la direzione più facile. Per spiegarsi meglio l’evangelista utilizza la formula quasi tecnica usata per la predicazione del vangelo, ma accostandola a un verbo di tutt’altro tenore: “divulgare”, “far pubblicità” (diafemízo), quasi a suggerire che l’uomo, preso dall’entusiasmo del momento che lo vede protagonista, e quasi per un senso di rivalsa rispetto alla situazione precedente di essere umano marginale, riduce la predicazione evangelica alla reclamizzazione della sua piccola esperienza illudendosi di dar lustro a Gesù.
Adesso, però, come detto, il Messia che l’ha toccato è impuro, contaminato dal peccato risanato nell’altro, tanto che sceglie, quasi in obbedienza alla prescrizione del Levitico, di non entrare in città, rimanendo fuori (come fuori della città sarà crocifisso), nel deserto, come il capro espiatorio di cui parla il cap. 16 del Levitico.
Infine, al versetto 44 Gesù ordina all’uomo di presentarsi ai sacerdoti secondo il rito prescritto, come fa altre volte invita ad attenersi alla norma sostenendo di non essere venuto ad abolire, ma a dare compimento, e ciò in questo caso significa che se è vero che il peccato diminuisce la nostra umanità e ci allontana da Dio e dagli altri uomini, è anche vero che questa condizione non è l’ultima parola sulla creatura ma è possibile un’altra via, perché la parola PECCATO in ebraico indica anche un FALLIRE IL COLPO; uno SBAGLIARE LA MIRA cioè una debolezza o incapacità più che un deliberato consenso a fare del male. Al contrario e letteralmente, il PERDONO È LASCIAR ANDARE VIA (I PECCATI; ma anche LIBERARE L’UOMO STESSO).
Gesù sembra avvertire la casta sacerdotale che “la legislazione levitica ha esaurito la propria funzione ed è tempo di chinarsi con più amore e compassione su chi sbaglia o soffre o è emarginato”.
Poiché poi la lebbra è considerata la malattia che lacera il corpo e le relazioni sociali, occorre “una LINEA DI LUCE per sanare, la luce non del Dio dei precetti, ma del Dio dalle viscere materne che si china sulla creatura che ama” (Franco Mastronardo).
Il nostro Dio non esclude nessuno, neppure il lebbroso peccatore perché il Signore è INCLUSIVO, anzi, davanti all’uomo, Gesù ha un interno terremoto divino, non riesce a non toccarlo perché come dice Ermes RonchI “Toccare è un’esperienza di comunione, di corpo a corpo, azione sempre reciproca: si tocca e si è toccati, inscindibilmente, è un comunicare la propria vicinanza, uno sfiorarsi, un brivido, un vibrare di Dio e i padri della chiesa a proposito dei sacramenti affermavano che essi erano il “TOCCO DI DIO”
Enzo Bianchi sottolinea a tale proposito che “questo dovrebbe essere l’atteggiamento del cristiano verso i malati e verso i peccatori, quando la cura e la misericordia diventano mano nella mano, occhio contro occhio, volto contro volto, un bacio come quello che Francesco d’Assisi seppe dare al lebbroso, quale segno di un’altra visione e dunque di un’altra (possibile) vita”.