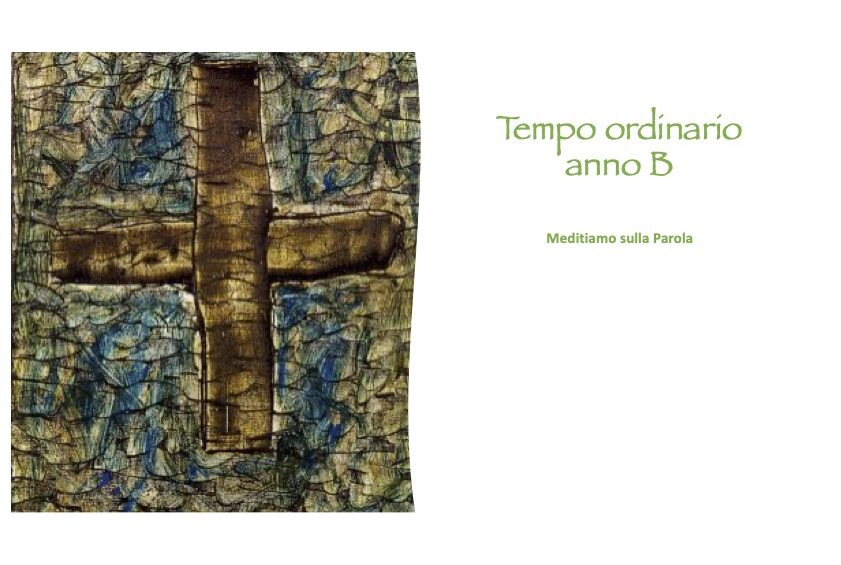
Meditiamo sulla Parola – XXVII domenica del tempo ordinario anno B
Nel corso del cammino verso Gerusalemme, la pagina evangelica di questa domenica ci presenta due episodi, il primo relativo al divorzio (10,2-12) e il secondo ai bambini (10,13-16).
Primo episodio
I farisei si accostano a Gesù e il loro intento è metterlo alla prova, come accade in Mc 8,11. Gli interpreti ritengono che il problema del divorzio fosse particolarmente avvertito nella comunità di Marco. In effetti, si trattava di una prassi abbastanza comune in tutto il medio oriente e nel mediterraneo; sul piano giuridico, il divorzio era disciplinato dal diritto privato, ed era consentito solo su iniziativa del marito. A quei tempi, il matrimonio era un semplice contratto, neppure scritto, e nel Primo Testamento non si riscontrava alcuna legge sul matrimonio. I farisei fanno riferimento al libro del Deuteronomio (Dt 24,1-4) in cui si legge: “Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso (‘erwat davar, lett.: “nudità di qualcosa”), scriva per lei un certificato di ripudio, glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa”. L’espressione “qualcosa di vergognoso” è alquanto vaga; infatti, i rabbini avevano proposto diverse interpretazioni. In particolare, a quel tempo si confrontavano due interpretazioni opposte. La prima, che faceva capo alla scuola del rabbino Shammaj, propugnava un’interpretazione restrittiva, facendovi rientrare solo il caso di lussuria della moglie, il che implicava fornire una maggiore tutela alla donna, la parte più debole. Una seconda, opposta, impostazione, facente capo alla scuola del rabbino Hillel, propendeva per un’interpretazione molto più ampia ed estensiva, facendovi rientrare di fatto tutto ciò che potesse risultare non gradito al marito. Di conseguenza, la donna aveva una tutela ben più ridotta, potendo il ripudio essere causato anche da cose di scarsa rilevanza (per esempio, lasciar bruciare il pasto, interpretato quale noncuranza verso il marito).
Come anche in altre circostanze, Gesù non entra nella casistica e non discute nel merito le diverse posizioni. Invita i farisei a fare altrettanto, proponendo loro un approccio diverso al problema: risalire alle intenzioni del legislatore. Notiamo anche il diverso verbo usato da Gesù: mentre i farisei chiedono se sia lecito o no ripudiare la moglie, Gesù chiede cosa Mose abbia ordinato loro, e i farisei rispondono parlando di permesso, quasi come se volessero aggirare la legge.
La risposta di Gesù è netta: questa norma fu scritta da Mosè per la durezza del cuore dell’uomo, una durezza (“sklerokardia”) che esprime una chiusura, una cattiva disposizione dell’animo alla comprensione del messaggio veicolato dalla Parola. La risposta di Gesù (“Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha congiunto”) richiama il libro della Genesi (Gn 2,18-24).
Come è noto, il capitolo 1 della Genesi narra della creazione dell’uomo al termine del racconto della creazione: “Dio creò l’uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò” (Gn 1, 21). La prima lettura di questa domenica riporta, invece, i versetti del capitolo 2: “…l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e rinchiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio plasmò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta essa è carne dalla mia carne e osso dalle mie ossa. La si chiamerà donna perché dall’uomo è stata tolta»”.
Si osservi che, nei testi biblici, la parola “aiuto” è usata unicamente con riferimento a Dio; il suo utilizzo in questo brano intende, quindi, sottolineare che l’uomo rappresenta per la donna (e viceversa) “la compagnia trascendente di Dio”. La declinazione al maschile del brano va attribuita solo a motivi culturali. Il termine ‘uomo’ andrebbe, quindi, inteso come sinonimo di essere umano, cui poi si aggiunge la specifica “maschio e femmina li creò”, affinché insieme vivano “la storia dell’amore, la storia della vita, l’uno di fronte all’altra, volto contro volto, in una reciproca responsabilità, chiamati nel loro incontro a diventare una sola realtà, una sola carne” (E. Bianchi).
La narrazione prosegue con l’approfondimento del significato delle parole di Gesù con i discepoli in privato. Si evidenzia, quindi, un’attenzione del Maestro verso i discepoli. La spiegazione ulteriore fornita da Gesù chiarisce un aspetto importante: il ripudio dell’uomo e il ripudio della donna sono posti sullo stesso piano: poiché il matrimonio è indissolubile, chi ripudia il proprio coniuge e si unisce a un nuovo partner è considerabile quale adultero. Ciò riflette un’usanza greca e romana, mentre per gli ebrei solo l’uomo poteva ripudiare la moglie, evidenziando come il problema fosse particolarmente avvertito dalla comunità di Marco che si trovava a Roma. Si tratta di un’aggiunta straordinaria per la cultura del tempo, considerando che Gesù pone sullo stesso piano la responsabilità dell’uomo e quella della donna.
Secondo episodio
Il brano evangelico prosegue con un secondo episodio, che appare distante rispetto al primo. La scena è completamente diversa. Dei bambini sono portati a Gesù affinché li accogliesse e li benedicesse. I discepoli hanno una reazione negativa e cercano di allontanare i bambini; in effetti, a quel tempo i bambini di età inferiore ai 12 anni non contavano nulla, per cui il comportamento dei discepoli è plausibile. La relazione con un rabbi era considerata una relazione importante che riguarda gli adulti, quelli che sono in grado di conoscere e osservare la Torah, non i bambini. Tuttavia, Gesù reagisce duramente, si indigna e rimprovera i discepoli perché i bambini, come gli altri “esclusi”, hanno un loro posto nel regno di Dio. Per Gesù, i bambini e, in termini più ampi, tutti coloro che sono simili ai bambini perché piccoli o scartati e messi ai margini, sono i primi destinatari del Regno. Alcuni commentatori vedono qui un riferimento all’innocenza dei bambini, per cui gli adulti per entrare nel regno devono recuperare e far ri-emergere questa condizione di innocenza. Tuttavia, si ritiene che il riferimento sia piuttosto alla condizione di povertà, di esclusione, di piccolezza dei bambini. Il bambino si trova fisiologicamente in una situazione di bisogno, per sopravvivere si affida ai genitori. “I bambini, proprio per il loro status sociale, sono coloro che non possono accampare pretese, ma possono esercitarsi solo a sviluppare la capacità di accoglienza, di abbandono fiducioso” (L. Monti, p. 74). Il messaggio è allora chiaro: superare la logica dei meriti e delle prestazioni nei confronti di Dio (si veda, per esempio, il brano del fariseo in Lc 18,11-12), e farsi piccoli creando spazio affinché Dio possa prendere posto in noi. I discepoli sono, quindi, ammoniti da Gesù e invitati ad accogliere gli esclusi, i poveri, gli ultimi ai quali Gesù rivolge la sua tenerezza, la sua benedizione, il suo abbraccio, affinché non si sentano più abbandonati o messi ai margini.