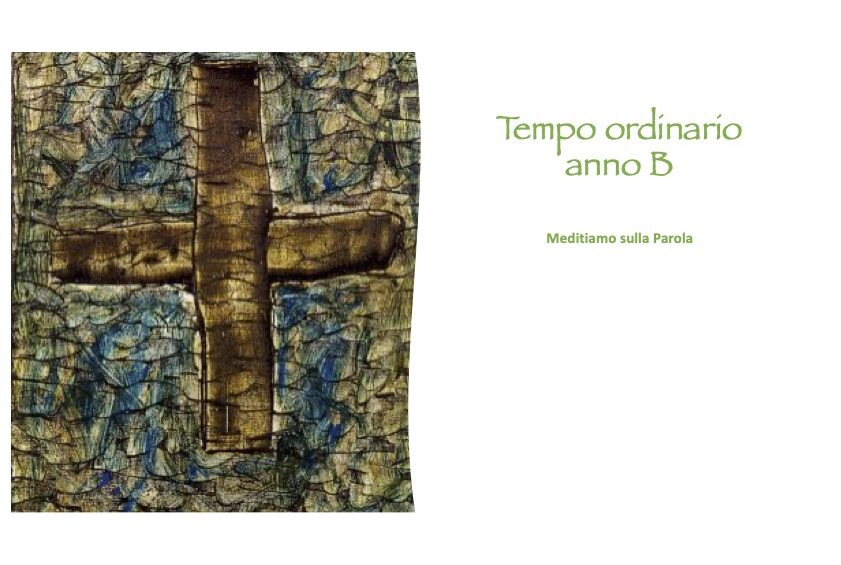
Meditiamo sulla Parola – XXXI domenica anno B
Mc 12,28-34
Uno scriba che ha appena ascoltato la discussione di Gesù con i sadducei a proposito della resurrezione dei morti (Mc 12,18-27) e ha apprezzato la sua sapienza, si avvicina a lui per chiedergli: “Qual è il primo di tutti i comandamenti?”. Domanda che nasce da un’esigenza assai diffusa nell’ambiente religioso del tempo di Gesù: operare una sintesi dei precetti di Dio presenti nella Torah (613, secondo il Talmud babilonese), così da giungere all’essenziale, a ciò che costituisce l’intenzione profonda del cuore di Dio, della sua offerta di vita e di senso a tutta l’umanità. Vi era anche una radicata tradizione di chiedere ai rabbini di fare una sintesi dei 613 comandi della legge giudaica di cui 365, quanti i giorni dell’anno, erano divieti e 248, quante le membra del corpo umano, erano ingiunzioni positive. Gesù risponde citando come primo comandamento l’inizio dello Shema‘ Jisra’el (Dt 6,4-9), la grande professione di fede nel Signore Dio ripetuta tre volte al giorno dal credente ebreo, centrale in tutta la tradizione rabbinica: “Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è uno. Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze” (Dt 6,4-5). “Ascoltare” non è solo una questione di orecchio: vuol dire accogliere, capire anche con il cuore. In pratica vuol dire avere fede, essere testimoni dell’unità di Dio. Fede del cuore: “Faremo e ascolteremo” (Es 24,7); “Ascolterai, Israele, e osserverai per fare” (Dt 6,3). “Ascolta” è anche la via della testimonianza, come se ognuno dicesse al suo vicino: “Ascolta, anch’io credo che Jhwh nostro Dio, Jhwh è Uno”. Le parole del Deuteronomio riprese da Gesù sembrano tracciare un movimento che dall’ascolto (“Ascolta, Israele”) conduce alla fede (“Il Signore è il nostro Dio”), dalla fede alla conoscenza (“Il Signore è uno”) e dalla conoscenza all’amore (“Amerai il Signore”)…
Al Dio che ciama di un amore eterno (Ger 31,3), che ci ama per primo gratuitamente (1Gv 4,19), si risponde con un amore libero e pieno di gratitudine, che si radica nell’ascolto obbediente della sua Parola, fonte della fede. Fidarsi di Dio significa fidarsi del suo amore della sua capacità di amare, del suo essere amore (1Gv 4,8.16). Ma cosa significa amare Dio con tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze. Che amore è mai questo verso un tu invisibile, “tre volte santo” (Is 6,3), cioè altro, distinto da chi ama? Nella tradizione cristiana incontriamo almeno due risposte diverse a tale questione. In Agostino e in una lunga tradizione spirituale dietro a lui, l’amore verso Dio da parte del credente è un amore di desiderio, un sentimento, una dinamica per cui il credente va alla ricerca dell’amore e dunque ama l’amore. Il linguaggio di questo amore è sovente quello presente nel Libro dei Salmi:
- Io ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia rupe, mia difesa, mio liberatore (Sal 18,2-3).
- L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente (Sal 42,3).
- La mia anima ha sete di te, a te, mio Dio, anela la mia carne (Sal 63,2).
Dio è oggetto di amore da parte dell’essere umano, perché è il “tu” che con il suo amore preveniente desta l’amore del credente come risposta; l’amore per Dio può essere un amore più forte di quello nutrito per se stessi o per qualche altra persona. Non si tratta di un amore totalitario che esclude altri amori, ma è un amore appassionato, un amore in cui non c’è timore (1Gv 4,18). Un amore che supera e ri-orienta tutti gli altri amori. Ma nella spiritualità cristiana è presente anche un’altra interpretazione dell’amore per Dio. È quella che legge nell’amore per Dio un amore obbediente, nel senso di un amore che nasce dall’ascolto (ob-audire), di un amore che risponde “amen” alla parola del Signore e all’amore stesso del Signore sempre preveniente. È un amore non di desiderio, di ricerca, di nostalgia, ma di adesione; è un amore con cui il credente cerca di realizzare pienamente la volontà di Dio, cerca di vivere come vuole il suo Signore e così mostra di amarlo. “Se mi amate, osserverete i miei comandamenti” (Gv 14,15); “se uno mi ama, osserverà la mia parola” (Gv 14,23). E ancora: “Questo è l’amore di Dio, osservare i suoi comandamenti” (1Gv 5,3). In questa seconda ottica l’accento cade quindi sull’amore del prossimo comandato da Dio: realizzare questo comando, sintesi di tutta la Legge e i Profeti (Rm 13,10; Gal 5,14), significa amare Dio. Dunque amare Dio è innanzitutto amare l’altro come Dio lo ama, perché – come ha chiarito una volta per tutte il discepolo amato – “chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede” (1Gv 4,20). È in questo senso che possiamo comprendere la decisiva innovazione compiuta da Gesù, il quale accosta il comandamento dell’amore per Dio a quello dell’amore per il prossimo: “Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Lv 19,18). L’innovazione consiste per l’appunto nell’abbinamento di questi due passi della Torah, dato senza paralleli nella letteratura giudaica antica, ripreso invece con frequenza dai successivi scritti cristiani. Un antichissimo scritto cristiano delle origini, la Didaché: “La via della vita è questa: innanzitutto amerai il Dio che ti ha plasmato e poi il prossimo tuo come te stesso; e tutto ciò che non vorresti fosse fatto a te, neppure tu fallo a un altro” (1,2). Gesù stabilisce una precisa gerarchia tra i due precetti, ponendo l’amore per Dio al di sopra di tutto. Nello stesso tempo, però, egli discerne che amore di Dio e del prossimo sono in stretta connessione tra loro: la Legge e i Profeti sono riassunti e dipendono dall’amore di Dio e del prossimo, non l’uno senza l’altro. Non a caso nella versione di Matteo il secondo comandamento è definito simile al primo (Mt 22,39), mentre l’evangelista Luca li unisce addirittura in un solo grande comandamento: “Amerai il Signore Dio tuo … e il prossimo tuo” (Lc 10,27). Se è vero che ogni essere umano è creato da Dio a sua immagine (Gen 1,26-27), non è possibile pretendere di amare Dio e, contemporaneamente, disprezzare la sua immagine sulla terra: una profonda unificazione del pensare, parlare e agire alla quale Gesù invita. Una comprensione riassuntiva delle sante Scritture porta dunque Gesù – il cui parere è condiviso dal suo interlocutore – ad affermare che l’uomo compiuto, l’uomo “non lontano dal regno di Dio” è colui che, amando Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze sa amare il prossimo come se stesso. E il prossimo è colui al quale ci facciamo prossimi, vicini, come Gesù ha affermato nella parabola del samaritano (Lc 10,36-37). Nel vangelo di Gv, quando dà l’ultimo e definitivo comandamento, “il comandamento nuovo”, Gesù compie un ulteriore passo avanti: “Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati” (Gv 13,34; 15,12), senza misura, “fino alla fine” (Gv 13,1). In questa sintesi, Gesù non ha neppure esplicitato la richiesta di amare Dio, perché quando gli umani si amano in verità, quando si amano come lui li ha amati, nel fare questo vivono già l’amore di Dio.
Dio non abbandona nessuno, ma domanda a noi di diventare suoi collaboratori per trasformare il nostro mondo. L’insegnamento di Gesù salda insieme in un unico comandamento l’amore di Dio e l’amore del prossimo. L’intervento di Gesù si chiude con queste parole: “Non c’è altro comandamento più grande di questi”. L’unità di amore di Dio e amore del prossimo costituisce il cardine di una vita che vuole realmente essere “cristiana”. Lo scriba non è lontano dal Regno, gli resta un passo da compiere. Quello decisivo. Non è ancora un cittadino, lo può diventare se fa quel passo. Dovremmo sempre tener presente questo particolare, ad evitare pericolose illusioni. Mai ritenerci “dentro”, definitivamente. Credere di tenere in tasca la cittadinanza, e relativi diritti. Cristiano è soltanto uno che lo sta diventando. Che ha sempre ancora un passo da compiere. Fino all’ultimo giorno.