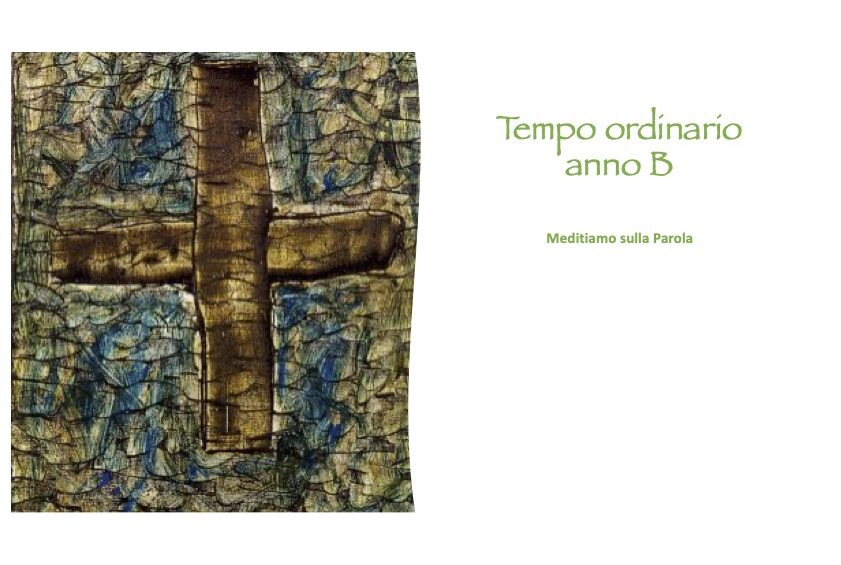
Meditiamo sulla Parola – XXXIII Domenica tempo ordinario anno B
Marco 13, 24-32
Con la XXXIII Domenica del T.O. si conclude la lettura continuativa dell’Evangelo secondo Marco; nella domenica che seguirà, infatti, la XXXIV, che chiuderà quest’anno liturgico B con la solennità di Cristo Re, si ascolterà la Parola tratta dall’Evangelo secondo Giovanni.
La pagina che consideriamo fa parte del cap. 13 dell’Evangelo di Marco. Tutto questo capitolo racchiude il cosiddetto “discorso escatologico” fatto da Gesù ai discepoli prima della sua Passione. I capitoli successivi (14, 15, e l’ultimo, il 16) contengono tutto il racconto della Passione, Morte e Risurrezione del Signore Gesù.
Dal v 1 al v 23 di questo capitolo c’era stato l’annuncio di vari eventi, causa di grande sofferenza agli umani: la distruzione del tempio di Gerusalemme (vv1-2), l’accadere di violenze, guerre, calamità naturali (vv7-8); persecuzioni, processi, odio (anche tra familiari) contro i seguaci del Signore (vv9-13); grande desolazione (vv14-20); il sorgere di falsi Cristi e falsi profeti (vv21-22).
Il brano che consideriamo fa volgere l’attenzione, lo sguardo, dalla Terra e dall’umanità, al Cielo, a tutto il Cosmo.
Lo sconvolgimento del Cosmo è descritto con espressioni tipiche del linguaggio apocalittico (un linguaggio che vuole essere rivelativo, profetico). L’oscurarsi del Sole e della Luna è una immagine che deriva da Isaia 13,10; la caduta delle stelle e lo sconvolgimento delle potenze che sono nei cieli deriva ancora da Isaia 34,4. Bisognerebbe conoscere il contesto in cui sono presenti queste frasi… Nel Primo Testamento queste immagini sono usate per descrivere il Giorno di YHWH, Giorno ultimo in cui Dio avrebbe salvato i suoi fedeli e condannato gli empi. Soprattutto la letteratura apocalittica legava la rappresentazione del “Giorno” con le immagini delle piaghe del fuoco e delle tribolazioni (cf Dn 7,11; Ap 20,9s; 2Ts 1,8). Questo genere letterario era molto diffuso dal II sec. a.C. al I sec. d.C. e oltre. Questa tipologia di linguaggio era comprensibile per le persone dell’epoca; lo è molto meno per noi, lontani nel tempo e dalla mentalità giudaica.
Il versetto 26 (E allora vedranno il Figlio dell’uomo che viene in nubi con molta potenza e gloria) è il “logion” (frase e messaggio centrale) di tutto il discorso, che fonda la speranza cristiana nella salvezza escatologica dei giusti. Viene stabilito un nesso tra la venuta del Signore e la fine dei tempi. Le “nubi” indicano la presenza di Dio. L’apparizione del Figlio dell’uomo sarà contrassegnata da potenza e gloria, due attributi che indicano la sua sovranità divina. Lo sconquasso del cosmo va considerato come “cornice” per l’unico avvenimento decisivo: la venuta del Figlio dell’uomo. L’accento del brano, quindi, cade sulla Parusìa del Signore Gesù.
Nella prima azione del Figlio dell’uomo emerge il vero significato della sua Parusia finale: la salvezza escatologica del popolo di Dio sparso in tutto il mondo e in ogni tempo; gli eletti verranno raccolti dagli angeli… Nessuno sarà dimenticato. Essi saranno uniti al Figlio dell’uomo, Signore Salvatore, il quale li renderà partecipi della vita eterna, di comunione piena, nel Regno.
Il discorso, perciò, non mira a spaventare ma a proporre un messaggio di speranza per la comunità cristiana; quella di Marco era provata dalle tribolazioni e perseguitata dai nemici dell’Evangelo. Due parabole inquadrano tre “detti” (vv 30-31-32) di Gesù. Con la parabola del fico si annunzia la vicinanza del Regno, della venuta del Figlio dell’uomo e si esorta a discernere i segni dei tempi; con quella del portinaio (v34) è sottolineata l’assoluta ignoranza del momento (Kairos) della Parusìa. L’imperativo (imparate) è un invito a penetrare a fondo il senso delle parole di Gesù. La pianta del fico perde le foglie in Autunno avanzato e le rimette tardi rispetto alle altre piante, a Primavera inoltrata, preannunciando prossima l’Estate. Il soggetto sottinteso dell’espressione “è vicino” è il Figlio dell’uomo, la cui venuta è considerata vicina (alle porte).
Con una dichiarazione solenne (In verità…) viene ribadita l’imminenza della fine e della Parusìa del Signore, conforme all’attesa comune all’epoca di Marco. Sono state fatte molte ipotesi sul significato di “questa generazione” (espressione spesso usata nella Sacra Scrittura). Più che una affermazione cronologica, si tratta di un’espressione cristologica (ha un contenuto cristologico): la salvezza si attua nella Pasqua di Cristo Gesù.
“Il cielo e la Terra” indica la totalità del cosmo. L’essenziale per il credente non consiste nella conoscenza del momento della Parusìa sulla base di vari calcoli temporali, ma nella ferma adesione alle parole di Gesù, che non passeranno mai. Su di esse si fonda saldamente la speranza del credente che si affida al Padre celeste.
L’ultimo versetto del brano (v32) è di transizione tra ciò che è stato detto finora e ciò che seguirà nella parte conclusiva del capitolo (vv33-37). In esso si ha la risposta alla domanda dei discepoli, al “quando” (v4) [Di’ a noi quando sarà questo e quale sarà il segno quando tutto questo starà per compiersi.]. La fine è certa ma la conoscenza del momento preciso è riservata esclusivamente al Padre. La fine è avvolta nel più profondo e insondabile mistero del Padre. Ha fatto sempre difficoltà la dichiarazione che neppure il Figlio conosce il momento della fine del mondo. Eppure, non sussiste nessuna remora teologica per accogliere tale affermazione di Gesù: “se si accetta seriamente l’incarnazione del Logos divino, la kenosi volontaria del Figlio di Dio, la sua solidarietà con la condizione umana, vi è la possibilità che Gesù ignorasse il giorno e l’ora della fine del mondo.”
Per la comunità di Marco e per tutti i credenti è essenziale avere fiducia che Dio resta il Signore della Storia e degli eventi finali del mondo. Il male condiziona il cammino dell’umanità ma Dio non rinnega la Creazione e porterà la perfezione finale di ogni cosa.
L’evangelista traccia l’itinerario della comunità cristiana chiamata a resistere alla prova e a diffondere la “buona/bella novella” nonostante le persecuzioni (vv9-10). Essa è invitata a vigilare, mantenendo viva la speranza per l’appuntamento decisivo con il Cristo.
È significativo che questo capitolo 13 si chiuda con i versetti dal 33 al 37, gli stessi con i quali si è aperto quest’anno liturgico B nella prima Domenica di Avvento, il 3-12-2023. La lettura continuativa dell’Evangelo di Marco inizia e si conclude con l’esortazione alla vigilanza, per essere pronti all’incontro col Signore.
Si tratta di restare vigilanti, desti, capaci di “leggere” i segni della salvezza nella Storia, nella realtà quotidiana, ascoltando la Parola di Dio, che sempre risuona nell’«oggi», e praticandola.