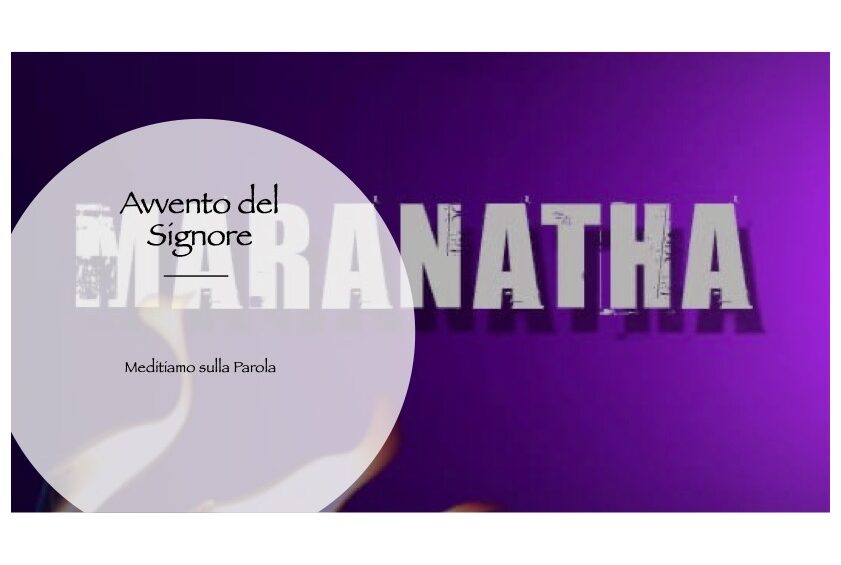
Vangelo e denaro: quale relazione? Riflessioni per il periodo di Avvento (anno C) – I parte
“Vangelo e denaro: quale relazione”? Riflessioni per il periodo di Avvento (anno C)
Durante il periodo di Avvento, proponiamo delle riflessioni sul rapporto tra Vangelo e denaro. Cercheremo di interpretare il nostro rapporto con il denaro alla luce della Parola. Le riflessioni che proponiamo traggono spunto dal testo di Enrico Chiavacci, Teologia morale, vol. 3/1, Teologia morale e vita economica.
La riflessione della teologia morale in ambito economico è stata sostanzialmente carente.
In modo forse implicito, la riflessione teologica ha accettato le impostazioni dell’economia neoclassica, confidando nelle teorie che modellizzavano il funzionamento dell’economia in termini di equilibrio, con il mercato capace di auto-regolamentarsi. Ciò ha condotto, da un lato all’accettazione acritica delle leggi civili in ambito economico, dall’altro alla focalizzazione prevalente sulla proprietà privata, di fatto anch’essa accettata quasi come un dogma da non mettere in discussione. Tuttavia, Lev 25,23 e, più in generale, le discipline dell’anno sabbatico avevano la finalità di impedire sia l’arricchimento, sia la schiavitù perenne, sia la stessa ‘mentalità’ di proprietario. In sostanza, l’inviolabilità della proprietà privata è stata posta in primo piano: ogni altro dovere morale in materia economica è stato posto in secondo piano e affrontato solo compatibilmente con tale inviolabilità. Specularmente, la riflessione teologica non si è occupata delle modalità di svolgimento dell’attività economica.
Tuttavia, ci si dovrebbe interrogare sul se e in che misura il rispetto della proprietà privata possa essere considerato il tema etico essenziale e se la teologia morale possa ignorare il dramma di una umanità che nella sua maggioranza muore di fame, anche a causa di come è strutturata l’attività economica.
La logica evangelica ci spinge a considerare le ricchezze quali mezzi, da utilizzare a beneficio della società, e non quale fine in sé stesso, poiché ciò inevitabilmente spalancherebbe le porte all’idolatria e all’ingiustizia. Il primo dovere di giustizia di chi ha è di dare al povero meglio che si può.
In effetti, questo tipo di riflessioni erano state proposte da figure di spicco del pensiero cristiano.
Secondo san Tommaso d’Aquino, l’etica deve orientare le abitudini e i comportamenti dell’uomo e l’etica economica, anche se riconosce la difesa naturale della proprietà privata e la liceità/necessità di svolgimento dell’attività economica, è basata sul concetto di «giusto prezzo». “Il commerciante non può aumentare il prezzo se non per provvedere alle proprie necessità e onesto sostentamento”. Considerazioni simili le riscontriamo anche in Sant’Antonino Vescovo di Firenze e San Bernardino da Siena (il primo a proporre una riflessione sul concetto di rischio quale elemento tipico dell’attività economica).
Va, però osservato, che il contesto economico in cui queste riflessioni erano proposte era semplice e circoscritto a un villaggio (ossia a un’area piccola). In un contesto quale quello odierno, in cui l’economia-mondo è l’intero pianeta, come si applica il concetto di giusto prezzo? Inoltre, il contesto odierno è largamente basato sulla deregolamentazione (che forse è la negazione dell’idea di giusto prezzo), su un diverso rapporto tra poteri economici e potere politico e sulla separazione tra proprietà e controllo nello svolgimento delle attività economiche. Ne consegue che continuare ad assumere che leggi civili in ambito economico siano in grado di condurre al bene comune non è in linea con il contesto economico odierno.
Probabilmente, la carenza di una riflessione teologica in ambito economico è dovuta alla circostanza che le teorie neoclassiche garantivano (o sembravano garantire) una stabilità di fondo. L’impostazione di Keynes era considerata pericolosa, quasi come se aprisse le porte al marxismo, considerato ateo e quindi pericoloso per la fede.
È tempo di rimettere in discussione il nostro comportamento in ambito economico, per recuperare l’idea di bene comune che sembra essere stata abbandonata. Il documento Gaudium et spes (1965), in modo profetico, ci propone il concetto di «bene comune del genere umano» (n. 78), un concetto innovativo e denso di implicazioni. La convenienza economica personale va commisurata alla convenienza economica della società in cui si vive e dell’umanità a cui si appartiene. Ragionare sulla base della logica «avere per avere ancora», significa seguire una logica inversa rispetto a quella evangelica. Infine, il cristiano dovrebbe anche iniziare a riflettere di più sull’impatto che le scelte economiche possono avere sull’ambiente. Nessuno ha intenzione di affamare il povero che vive agli antipodi o di defraudare le generazioni future delle risorse naturali; tuttavia, le scelte economiche del singolo possono avere queste conseguenze.