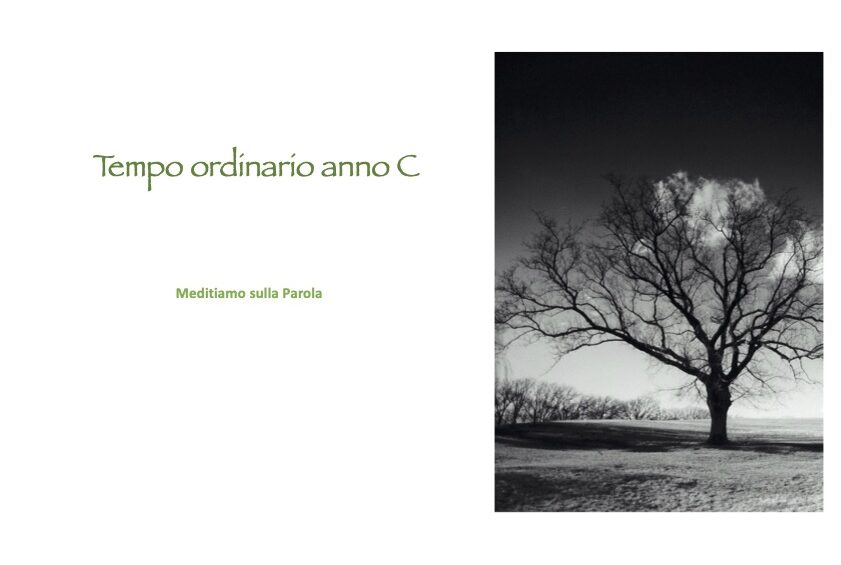
Meditiamo sulla Parola – VI Domenica tempo ordinario anno C
Lc 6,17.20-26
La pagina tratta dal Vangelo di Luca, detta delle Beatitudini, è fra i passi più letti e commentati dell’intero vangelo: le troviamo nel vangelo di Matteo (discorso della montagna), in quello di Luca (discorso della pianura) e lo troviamo anche nel vangelo apocrifo di Tommaso, ma in una versione di pochi versetti.
Nella liturgia di domenica siamo al capitolo 6, un momento in cui accadono tante cose: di sabato i discepoli colgono le spighe e vengono attaccati dai farisei; sette giorni dopo, sempre di sabato, Gesù guarisce l’uomo dalla mano paralizzata e si attira nuove critiche; nei giorni successivi, dopo aver a lungo pregato da solo sul monte, sceglie gli apostoli poi scende in pianura e parla; al temine del discorso, oggetto della presente riflessione, e dopo istruzioni varie, racconta la parabola dei due ciechi e poi quella della casa costruita sulla roccia. Un’intensa attività che regala a piene mani parole e segni, con un incalzare di gesti e concetti che sembrano rivelare un’urgenza, un’impellenza, una necessità che non può attendere.
E le Beatitudini si inseriscono perfettamente nel desiderio di spiegare ai discepoli qual è la strada per raggiungere la santità. René Costes (esegeta e professore di teologia) scriveva:” Il santo è l’uomo nuovo, quello che vive secondo il modello lasciato da Gesù Cristo, è l’uomo delle beatitudini, è l’uomo spogliatosi dal proprio egoismo che vive per dio e per gli altri, è l’uomo trasfigurato. È l’uomo veramente e pienamente umano”.
La struttura del brano della liturgia è tipica della prosa biblica: ad una serie di proposizioni che indicano ciò che è bene fare e a cui tendere con tutte le proprie forze si oppongono, in perfetto bilanciamento negativo, un’altra serie di frasi che iniziano con il greco OUAI’ che noi traduciamo con una parola dal suono simile GUAI, ma che più correttamente sarebbe AHIME’ o AHI, cioè una interiezione che perde, perciò, parte del significato intimidatorio che gli diamo in italiano acquistando una sfumatura più dolente. Addirittura, in ebraico il termine equivalente, che si legge OY, potrebbe anche tradursi con OH NO! Quindi dolore più che ammonimento per l’uomo che sceglie male o fallisce.
Riassumendo, a grandi linee, sono detti Beati i poveri (in spirito), coloro che hanno fame, coloro che sono afflitti fino alle lacrime, coloro che sono odiati a causa del Figlio dell’uomo, mentre ci si rammarica per i ricchi, i sazi, i lieti “a prescindere”, gli uomini di cui tutti parlano bene perché piacciono a tutti anzi, meglio, non dispiacciono a nessuno, equilibristi del consenso a spese della propria onestà e coerenza.
Queste frasi, scrive Enzo Bianchi, più che ordini, sono interrogativi rivolti a chiunque voglia condurre una vita degna di questo nome, e aggiunge: “Pochi anni dopo la morte e resurrezione di Gesù, il filosofo Seneca scriveva ‘tutti vogliono vivere felici (beate vivere) ma quando si tratta di veder chiaro cosa è che rende felice la vita sono avvolti dall’oscurità’; ebbene, dice ancora l’autore, le beatitudini sono una lampada in questo tendere verso la vera felicità, per ‘salvare’ il nostro cammino quotidiano.
Beati i poveri (in o di spirito) è la traduzione del versetto 20, peraltro veramente traditrice (si ricorda che una proposta per la prima parola, il termine ebraico ASHRÈ, che si deve a Erri De Luca è “Lieto” perché sostenuto, appoggiato da Dio, oppure secondo altri, come Enzo Bianchi “Avanti, coraggio”), un ebreo come Gesù, che conosceva il Primo Testamento non poteva non sapere che i poveri sono chiamati ‘ANAWIM’ che illustra, fisicamente, la posizione sottomessa e curva degli umili, umiliati di fronte al potente di turno. Forse sono uomini a cui mancano cose importanti per sopravvivere, ma ai quali soprattutto è stata sottratta la dignità e la speranza, così che sono costretti a dire sempre di sì.
Il povero nelle Scritture, sapendosi sempre ascoltato, può, però, invocare Dio e gridare il suo dolore e la sua preoccupazione di precipitare verso un impoverimento dell’animo, un abbrutimento che sarebbe davvero la sconfitta totale, i poveri del Signore nella Bibbia custodiscono nel cuore il senso della loro umiltà e sperano in Dio ed è bello ricordare che al tempo di Gesù il termine povero era sinonimo di CHASID cioè santo, separato, altro, perché di proprietà del Signore.
La povertà spinge a invocare Dio avendo chiaro nel cuore, prima che nella mente, i propri bisogni e i propri limiti, è un’abitudine, meglio, un’attitudine di apertura a Dio a partire da una necessità avvertita in sé stessi.
Non tutti i poveri, però, sentono nell’anima questo movimento verso Dio: la povertà, il dolore, la sofferenza non sono automaticamente la strada per ottenere uno sguardo “divino” sulla realtà. Anzi, tutti abbiamo esperienza che il rischio del contrario è dietro l’angolo, quello che si può però dire è che la condizione di bisogno (e tutti manchiamo sempre di qualcosa, dobbiamo solo ricordarcene, esattamente come il segno nella carne della circoncisione ebraica è il memoriale che tutti, ma proprio tutti, non siamo e non saremo mai sufficienti a noi stessi, a qualunque livello sociale apparteniamo, ci mancherà sempre un “pezzettino”), dovrebbe interpellare ognuno di noi a cui spetta la libertà di scegliere tra la via della comprensione e dell’amore o quella dell’odio, della violenza, dell’aggressione.
Nei cuori dei poveri che guardano verso Dio c’è, dice S. Girolamo: “L’attesa di una felicità che non possono procurarsi da sé ma che possono solo ricevere in dono da Dio”.
Gesù parla dei poveri e con i poveri, li ama profondamente e contemporaneamente mette in guardia tutti dal ricatto della ricchezza, da Mamon, l’idolo che ruba il cuore e impedisce la vita a sé e agli altri, perché il rischio grosso è di fare del possesso un simulacro più importante e grande, di se stessi e di Dio.
Il pericolo per i ricchi è il non saper condividere, non saper guardare ai poveri e ai loro bisogni minimi non soddisfatti, non accorgendosi di chi si ha accanto e dello stato in cui versa, perché Mamon ci ruba la vita facendoci concentrare sui beni materiali e il loro possesso. Perciò l’uomo viene messo seriamente in guardia dalla ricchezza che, vissuta così, genera il nemico assoluto di Dio che non è il peccato, che, se riconosciuto, è solo un fallire, uno sbagliare la mira. NO, il nemico è la non vita, cioè la morte provocata in sé per aridità e negli altri per colpevole omissione e disattenzione.
Per quanto appena detto diversi teologi sostengono che, quindi, il vero senso della povertà vissuta da Gesù, e dunque della povertà cristiana, è CONDIVISIONE.
E quest’ultima considerazione ci porta ad allargare il discorso alla Chiesa, passata, presente e futura. Nella LUMEN GENTIUM quarta costituzione del Concilio, promulgata da papa Paolo VI si legge: “Come Cristo ha compiuto la salvezza attraverso la povertà e le persecuzioni così pure la chiesa è chiamata a percorrere la stessa via” e potremmo aggiungere: noi con lei.
Se è vero che il numero dei cristiani, nominali, sta diminuendo ed è cosa che deve dispiacerci poco se vogliamo restare aderenti alla sostanza del vangelo e delle Beatitudini (meglio pochi che molti se troppo sazi, troppo ricchi, troppo ridenti, troppo amati, visto che la strada che ci viene invece consigliata è quella impervia che conduce a una porta stretta), è anche vero che la Chiesa nei secoli ha sempre condiviso in parte con i poveri la propria ricchezza, purtroppo solo in parte e non sempre abbastanza. Oggi viviamo un tempo di crisi di senso e noi dobbiamo, invece, chiedere che la Chiesa abbia sempre più senso perché se essa come dice Paolo nella lettera ai Filippesi (2,5) deve condividere i sentimenti che furono di Gesù, la Chiesa DEVE essere povera e serva (e perciò piacerà sempre meno ai più), deve tornare ad essere assemblea di santi e di poveri, incarnando la sposa bella che avrà diritto di gridare allo sposo: “HO BISOGNO, VIENI PRESTO, MARANA THA!”