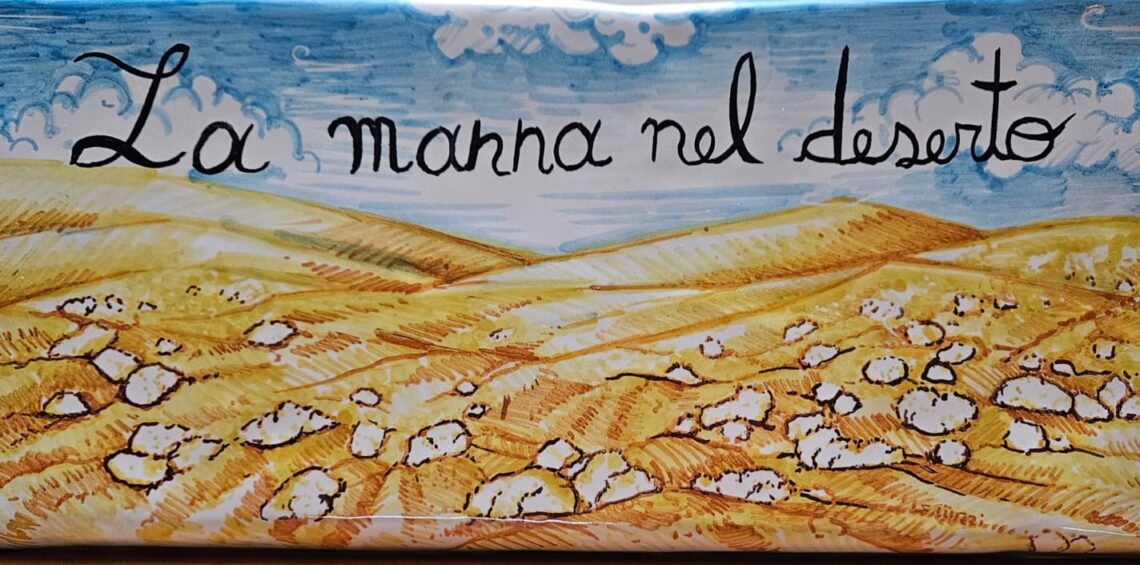
Meditiamo sulla Parola – Ascensione del Signore anno C
Lc 24,46-53
Siamo all’ultimo capitolo del vangelo di Luca che si è aperto, in perfetta continuità col capitolo precedente, con l’immagine delle donne che al mattino presto si recano al sepolcro e lo trovano vuoto, è il “primo giorno della settimana” dopo il sabato ovviamente e quindi siamo alla nostra domenica di Pasqua. Lo stesso giorno due discepoli stanno tornando sconsolati e delusi al loro villaggio di Emmaus e fanno un incontro straordinario che li convince a ripartire subito per Gerusalemme per avvisare gli apostoli, ma all’improvviso Gesù stesso compare e annuncia al gruppo piuttosto incerto e perplesso, che ciò che aveva loro promesso più volte si è avverato e per convincerli, siamo al v. 45 (non c’è nel brano che stiamo esaminando) fa una cosa tipica dei maestri quando si accorgono che la classe davanti a loro è poco convinta, una bella ripetizione, infatti Luca dice “allora aprì loro la mente per comprendere le scritture” e aggiunge (e qui ci siamo col nostro testo) “Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno,”.
Ed ecco il primo problema, nessun passo delle scritture letto e interpretato al tempo di Gesù faceva riferimento a un Cristo che soffre, muore e risorge, neppure il brano di Isaia del servo sofferente sarebbe stato letto in questa luce, mai gli ebrei del tempo di Gesù né quelli dopo e neppure oggi, hanno interpretato quei versetti o altri simili in riferimento al Messia, siamo noi cristiani che lo abbiamo fatto. Gli apostoli, dunque, sono in un certo senso giustificati per la difficoltà che fanno nel capire cose a cui non erano pronti anche se più volte le avevano ascoltate dalla voce stessa di Gesù.
La Pontificia Commissione biblica scrive a questo proposito: “La morte del Messia e la sua resurrezione diedero ai testi dell’AT una pienezza di significato prima inconcepibile alla luce degli eventi della Pasqua gli autori del N.T. rilessero l’antico” cioè il cristiano alla luce di Cristo scopre nei testi un più di significato che vi era nascosto, proprio perciò i discepoli cominciano, solo molto lentamente, a comprendere quello che prima non riuscivano a capire.
Enzo Bianchi scrive a tal proposito: “Nella potenza dello Spirito il Signore Gesù mostra ai discepoli il compimento delle Scritture e il compimento delle sue parole negli eventi che hanno preceduto quel giorno (cf. Lc 24,44-47). Il Risorto spiega le Scritture in modo che i discepoli comprendano la conformità tra lo “sta scritto” e ciò che hanno vissuto. Avevano certamente letto tante volte la Torah, i Profeti e i Salmi, ma ora che i fatti si sono compiuti possono comprenderli credendo, alla luce della fede.”
Gesù aveva annunciato loro più volte la sua passione e morte (cf. Lc 9,22.43-44), ma questi discorsi erano parsi loro scandalosi, enigmatici (cf. Lc 9,45). Ora, però, che si sono compiuti, non per destino o fatalità, ma per la necessità mondana secondo cui “il giusto” (Lc 23,47) in un mondo ingiusto deve soccombere (cf. Sap 1,26-2,22) e per la necessità divina per la quale Gesù in obbedienza alla volontà del Padre non si difende, ma accoglie l’odio su di sé amando fino alla fine, ora sì che è possibile credere alle sante Scritture. E credendo è possibile diventare “testimoni”, fino ad annunciare la morte e resurrezione di Cristo come evento che chiede la conversione e dona la remissione dei peccati: il perdono da parte di Dio a tutta l’umanità.
Tutti sono testimoni – sottolinea Luca – tutti annunciatori del Vangelo, non solo gli Undici, gli apostoli, ma da questo momento in poi, tutti i battezzati. La missione è chiara anche per noi: tutti devono convertire se stessi e gli altri (la metanoia), un completo cambiamento del sistema di riferimento usato per interpretare le cose, come se Luca dicesse: non pensate più a voi, non mettetevi al centro dei vostri pensieri e dei vostri bisogni, perché c’è altro da fare. La prima cosa, la più importante da comunicare è il perdono dei peccati “cominciando da Gerusalemme”.
E quest’ultima è una cosa molto forte detta da un ebreo ad altri ebrei: a Gerusalemme essi salivano per cercare il perdono di Dio con una serie di riti, con l’impiego cruento degli animali e del loro sangue, ma Gesù dice che non occorre più un luogo fisico, una liturgia specifica per trovare il perdono, occorre solo un profondo cambiamento che passa dal cuore al cervello perché è stato Cristo stesso l’ultimo agnello immolato in maniera definitiva (lo dice anche Paolo), tutto è compiuto.
- Bianchi scrive che a volte la Chiesa dimentica queste parole ed è tentata di attribuirsi compiti che il Signore non le ha dato, quello che, invece, deve fare è annunciare e fare misericordia, annunciare il Regno, servire i poveri, i malati, i sofferenti, stare accanto ai peccatori, tutti i peccatori, perché è il peccato da denunciare non chi ad esso cede.
E Gesù insiste con i suoi: di queste cose voi siete stati e siete testimoni (in greco martures) e martiri lo saranno tutti presto, non subito però, perché prima dice che riceveranno quanto promesso cioè la discesa dello Spirito stesso di Dio. Questo avverrà di lì a poco proprio in concomitanza con una data importante per gli israeliani: è la festa in cui si ricorda la consegna delle tavole della Legge sul Sinai a Mosè, con questa differenza: ai credenti in Cristo non viene lasciata una legge imposta da Dio, scritta su pietre per un popolo dalla dura cervice, quel tempo è superato, all’uomo viene donato un “giogo leggero”, il desiderio di assomigliare al Padre praticando un amore simile al suo verso gli altri, verso la natura, il mondo e la creazione tutta.
Intanto devono sedersi nella città, il testo dice proprio “sedete”, l’iniziativa passa a Dio, loro devono saper aspettare e affidarsi completamente al Padre, questa frase ricorda l’uso dei popoli slavi (soprattutto russi) che prima di partire per un viaggio, quando tutto è pronto, le valigie chiuse e i cappotti indossati, si siedono qualche minuto in silenzio con le persone che amano per trovare la forza di compiere il primo passo e di continuare ad andare.
Poi li conduce all’aperto, ma dove siamo? Genericamente sulla strada verso Betania. Chi va a Gerusalemme può visitare la chiesa dell’ascensione, poco lontano dall’orto degli ulivi, una costruzione ottagonale, già moschea, dove è conservata la pietra dell’ascensione che è un masso su cui la devozione e la tradizione vogliono sia rimasta incisa l’orma di un piede, non sappiamo con sicurezza dove collocare la scena del nostro brano che è cominciata nel luogo dove erano racchiusi tutti i discepoli.
In realtà le due zone (il cenacolo, se è questo il posto, e la chiesa dell’ascensione) non sono affatto vicine, sembra piuttosto che l’autore voglia riproporre, simbolicamente, il tragitto compiuto dallo stesso gruppo la notte del giovedì.
Si tenga presente che il verbo usato per indicare questo movimento di Gesù, seguito dai presenti, è lo stesso che viene usato per illustrare l’esodo dall’Egitto cioè l’uscita da una schiavitù, verso una terra promessa.
Poi non li benedisse, ma li benediva cioè un verbo all’imperfetto che nei Vangeli indica sempre continuità, cioè un’azione che si realizza ancora e ancora, perciò anche adesso su di noi, la sua benedizione galleggia sul mondo e lo “cova” come fa lo Spirito di Dio creatore all’inizio della storia dell’universo e il Cristo li benediva dopo aver alzato le mani un gesto sacerdotale che potrebbe ricordare le braccia stese sulla croce, aperte in un abbraccio universale
Poi Gesù viene portato verso il cielo, e i discepoli si prostrano stupiti e sorpresi, stranamente lieti perché, pur trattandosi di un addio, avranno forse intuito che nulla sarebbe stato più come prima, la presenza fisica è cancellata, ma niente avrebbe potuto strappare i tralci dalla vite.
E adesso ci vorrà solo la pazienza di attendere la discesa dello Spirito Santo perché tutto inizi.