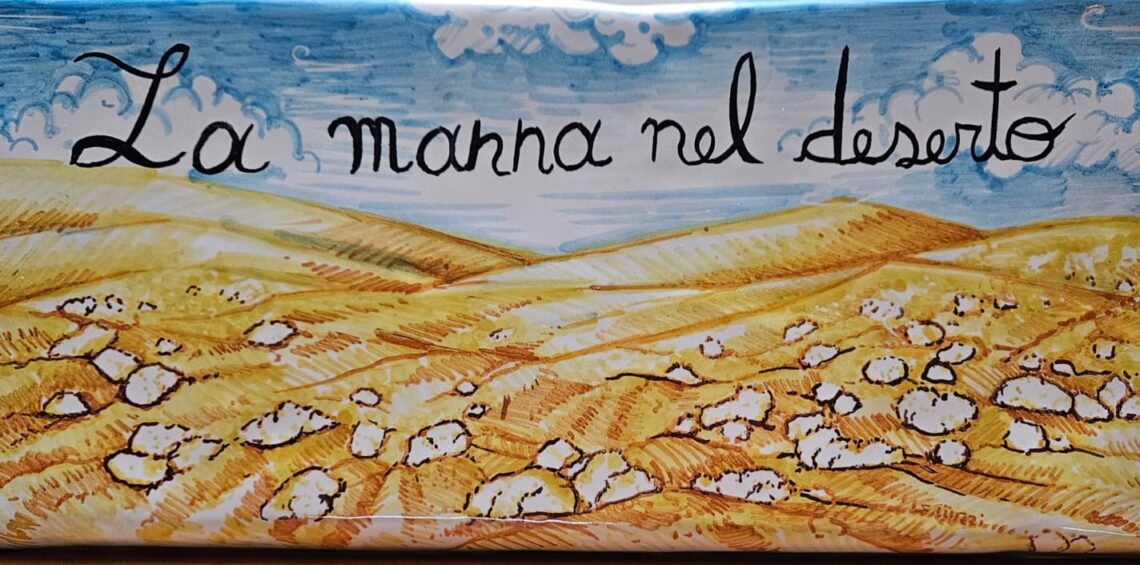
Meditiamo sulla Parola – XV Domenica tempo ordinario anno C
Lc 10,25-37
La pagina del vangelo ci presenta Gesù mentre sale a Gerusalemme. Sul suo cammino incontra un dottore della Legge, cioè gli esperti della Torah. Ogni volta che lo incontrano, e molto spesso gli incontri sono voluti, gli pongono domande o osservazioni per metterlo alla prova. Questi gli pone quindi una domanda classica: “Che fare per ereditare la vita eterna?”. Gesù risponde spesso con una contro-domanda, perché vuole che insieme si arrivi alla scoperta della verità: “Che cosa sta scritto nella Legge?”. L’esperto cita allora il grande comandamento attestato nel Deuteronomio, che ogni ebreo conosce a memoria e ripete tre volte al giorno, lo Shema‘ Jisra’el: “Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente”. Poi, con intelligenza spirituale, aggiunge il comandamento dell’amore del prossimo, estraendolo dal libro del Levitico. A questa sua giusta declamazione, Gesù non può fare altro che approvare e invita quest’uomo a mettere in pratica quotidianamente quanto ha saputo affermare.
Ma quell’esperto, volendo giustificare la sua domanda iniziale, lo interroga di nuovo: “E chi è il mio prossimo?”. Ancora una volta Gesù non risponde direttamente, perché, se acconsentisse alla domanda del suo interlocutore, dovrebbe dare una definizione del prossimo e così situarsi all’interno della casistica degli scribi e dei farisei, ai quali il dottore della Legge appartiene. No, il prossimo non può essere rinchiuso in una definizione, perché in verità il prossimo non è qualcosa che dobbiamo andare a cercare, sono le circostanze che ce lo fanno incontrare, prossimo è colui che decide di rendersi prossimo, colui che avvicina. Per farglielo comprendere meglio, Gesù racconta una parabola che mette in scena un sacerdote, un levita e un samaritano. I primi due sono figure legate al culto del tempio; il terzo è un ebreo scismatico, considerato come uno straniero, pagano e impuro. Sulla strada da Gerusalemme a Gerico, strada molto impervia che di solito si scendeva in carovana per evitare i briganti, il sacerdote e il levita si imbattono in un uomo moribondo, che i briganti hanno assalito, derubato e abbandonato. È una persona anonima, di lui non sappiamo nulla né nazionalità, né condizione sociale, né appartenenza religiosa né perché era andato a Gerusalemme. La Legge del Signore in situazioni simili prevedeva l’obbligo di soccorrerlo, ma il sacerdote e il levita passano oltre senza fermarsi. Erano di fretta… uomini ai quali è affidata la cura del tempio di Dio a Gerusalemme, erano bravi osservanti e siccome per due settimane all’anno dovevano prestare servizio a Gerusalemme presentandosi lì puri, non potevano avvicinare né morti né feriti altrimenti dovevano di nuovo purificarsi, forse questa potrebbe essere una delle ragioni del non fermarsi. E qui la parabola ci offre un primo insegnamento: non è automatico che chi frequenta la casa di Dio e conosce la sua misericordia sappia amare il prossimo. Si possono conoscere tutta la Bibbia, le rubriche liturgiche, la teologia, ma dal conoscere non è automatico l’amare: l’amare ha un’altra strada, è qualcosa di più… Se non ci avviciniamo a quell’uomo, a quella donna, a quel bambino, a quella persona anziana che soffre, non ci avviciniamo a Dio. Il sacerdote e il levita non hanno assimilato il sentimento primo di Dio verso chi è nel bisogno, un Dio che non vuole preghiere, offerte, liturgie ma vuole solo amore per l’uomo. e per fare questo non ci devono essere leggi, precetti altri impedimenti vari, che ci devono bloccare.
Nulla di straordinario in questo fatto che è quotidiano nelle nostre città, soprattutto dove i banditi borseggiano, strattonano, malmenano e finiscono per lasciare le persone aggredite a terra sulla strada… Vanno via anche in fretta, non hanno il tempo per prestare soccorso a un fratello. Anche oggi i sacerdoti non hanno tempo per ascoltare un fratello che si rivolge loro in cerca di aiuto, di ascolto. Donare il tempo invece significa donare parte di se stessi, il tempo è dono gratuito e non ci viene restituito. Regola questa che per il sacerdote e il levita purtroppo viene prima dell’aiuto all’uomo.
Ciò che sorprende nel prosieguo della parabola è che al sacerdote e al levita, i tipici religiosi, Gesù oppone un samaritano, l’anti-tipo, cioè il perfetto contrario dei due osservanti e puri giudei. La definizione di samaritano era una definizione negativa, una persona da disprezzare, un eretico. Anche il samaritano, passando lungo quella strada, vede, e per vedere bene si avvicina, si fa prossimo all’uomo ferito: sono volto contro volto, e la prima emozione che prova è la commozione. Nel samaritano però non resta solo sentimento, ma si fa gesto, parola, prossimità. Papa Prevost ha affermato: «infatti, prima che una questione religiosa, la compassione è una questione di umanità! Prima di essere credenti, siamo chiamati a essere umani».
Il samaritano versa olio e vino sulle ferite, le fascia, subito si dà da fare, poi lo carica sul suo giumento e lo conduce all’albergo. In effetti non si intende qui albergo ma il termine esprime un luogo dove vengono accolti tutti, Gesù è venuto a prendere l’umanità ferita e la porta nel luogo dove c’è uno che accoglie tutti, nessuno viene mandato via, escluso. Così carica quell’uomo e lo conduce lì, affidandolo al locandiere per le cure e la convalescenza. Il giorno seguente lascia due denari all’uomo che accoglie tutti, in modo che provveda alla sua assistenza. La compassione, l’amore, non sono sentimenti vaghi, ma esprimono il prendersi cura dell’altro fino a pagare di persona. L’amore è il contrario dell’indifferenza. L’identità del prossimo non più definita a partire dal donatore, ma a partire dal beneficiario.
Conclusa la parabola, Gesù ribalta la domanda del dottore della Legge e gli chiede: «Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?» (v. 36). La risposta è finalmente inequivocabile: «Chi ha avuto compassione di lui» (v. 27). All’inizio della parabola per il sacerdote e il levita il prossimo era il moribondo; al termine il prossimo è il samaritano che si è fatto vicino. Gesù ribalta la prospettiva: non stare a classificare gli altri per vedere chi è prossimo e chi no. Tu puoi diventare prossimo di chiunque incontri nel bisogno, e lo sarai se nel tuo cuore hai compassione, cioè se hai quella capacità di patire con l’altro. La misericordia è dunque la più radicale protesta contro l’indifferenza, l’individualismo, il rifiuto dell’altro. La misericordia è mistero che genera vita e comunione, è dinamica di condivisione.