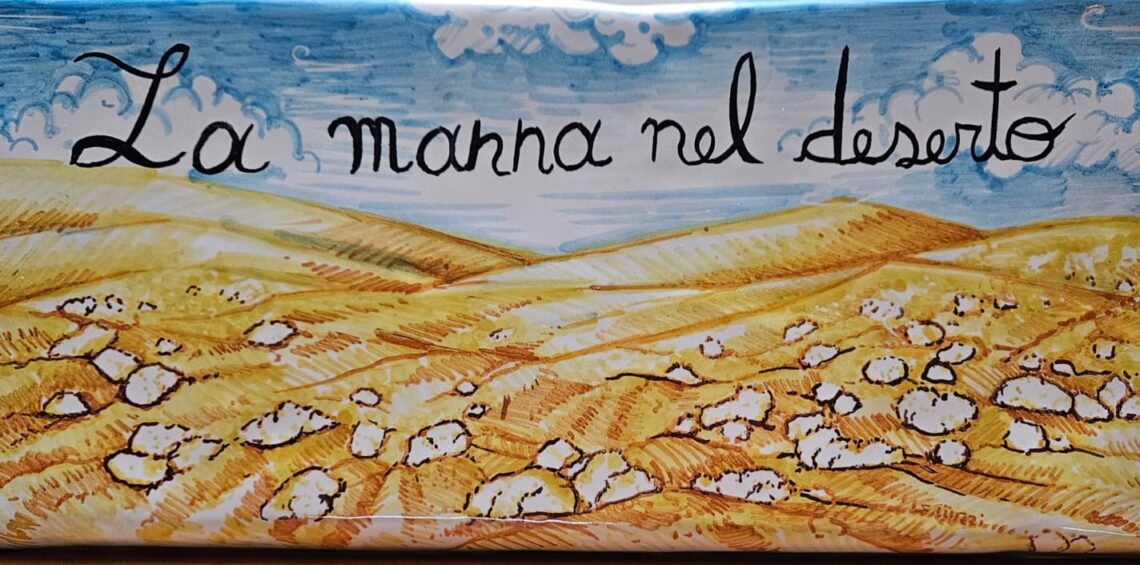
Meditiamo sulla Parola – XVII domenica tempo ordinario anno C
Lc 11,1-13
Nella pagina del Vangelo di questa domenica si distinguono tre sezioni: la prima con la richiesta di un discepolo di imparare a pregare e il dono del Padre nostro: vv.1-4; la seconda con la parabola dell’amico importuno: vv.5-8; la terza con alcuni insegnamenti di Gesù sulla preghiera: vv.9-13. Nel capitolo 11 è concentrata buona parte dell’insegnamento di Gesù sulla preghiera (un tema assai caro al terzo evangelista) la cui pietra angolare è la preghiera stessa di Gesù: è da essa che scaturisce la preghiera dei discepoli. Il capitolo si apre con una scena non rara nella vita di Gesù. Egli sta pregando. Per Luca questo atteggiamento accompagna i momenti più significativi della vita del Signore: il suo battesimo al Giordano (3,21-22), la rivelazione della sua identità messianica (9,18), la trasfigurazione (9,29). Anche sulla croce Gesù ha pregato per i suoi crocifissori (23,34) e le sue ultime parole prima di morire sono state proprio una preghiera (23,46: “Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio”. Detto questo, spirò). Il discepolo, affascinato dal modo in cui ha visto pregare Gesù, gli chiede che anche lui, come il Battista, diventi maestro di preghiera; il suo insegnamento diventi un dono per tutta la comunità dei seguaci. Così, la preghiera che Gesù trasmette ai suoi diventa per loro l’espressione caratteristica del loro ideale e identità, del modo di rapportarsi con Dio e con i fratelli. La preghiera del Padre nostro insegnata da Gesù non è una novità assoluta. Il tema della paternità di Dio era già noto nell’AT (Is 63,16: “perché tu sei nostro Padre, poiché Abramo non ci riconosce e Israele non si ricorda di noi. Tu, Signore, tu sei nostro Padre, da sempre ti chiami nostro redentore”; Is 64,7: “Ma, Signore, tu sei nostro Padre; noi siamo argilla e tu colui che ci dà forma, tutti noi siamo opera delle tue mani”). Gesù, come i grandi maestri religiosi del suo tempo, insegna ai suoi seguaci una preghiera totalmente propria. J. Jeremías: «Siamo di fronte a qualcosa di totalmente nuovo e inaudito, che supera i limiti del giudaismo. Qui scopriamo per davvero chi fu il Gesù storico: l’uomo che aveva la capacità di parlare con Dio come Abbà e che faceva partecipi del Regno peccatori e pubblicani, permettendo loro di ripetere quest’unica parola: Abbá, padre amato!».
– Padre: A differenza di Matteo, Luca non aggiunge l’aggettivo “nostro”, mettendo meno l’accento sull’aspetto comunitario della preghiera cristiana; il fatto di invocare lo stesso Padre costituisce il miglior legame dell’unità dei discepoli. Per un ebreo del 1º secolo, la relazione con il padre era fatta di intimità, ma anche di riconoscimento della sua autorità su ogni membro della famiglia. Il fatto che Gesù, per dirigersi al Padre, lo chiami abbà manifesta il tipo di relazione che Lui, e anche i suoi discepoli, instaurano con Dio: una relazione di vicinanza, familiarità e fiducia. Inoltre chiamare Dio Padre esige impegnarsi a vivere come suoi figli, come fratelli di tutti i suoi figli, senza escludere dal nostro amore neppure quelli che lo rifiutano, perché Lui è buono con gli ingrati e i malvagi. “Siate, perciò, misericordiosi come il vostro Padre è misericordioso” (Lc 6,36).
– santificato sia il tuo nome: Dio stesso “santifica il suo Nome” intervenendo con potere nella storia umana, sebbene Israele e gli altri popoli lo abbiano disonorato. È necessario che molti lo chiamino con quel nome di Padre e, così, gli uomini diventino suoi figli e il mondo degli uomini si trasformi in un mondo di fratelli.
La prima richiesta della preghiera non è rivolta all’uomo e al suo indiscutibile dovere di onorare e rispettare Dio, ma allo stesso Dio Padre affinché si dia a conoscere come tale da tutti gli uomini.
– Venga il tuo regno: Gesù ha sempre parlato della vicinanza definitiva del Regno di Dio: “Sappiate che il regno di Dio è vicino” (Lc 10,11). La preghiera di Gesù e del cristiano, pertanto, è in perfetta sintonia con questo annuncio. Chiedere che questo Regno sia ogni giorno più visibilmente presente, produce due effetti: chi prega si confronta con il progetto universale di Dio, inoltre, si pone in totale disponibilità verso la sua volontà di salvezza.
Per questo, anche se a Dio si possono e devono manifestare le proprie necessità, è anche vero che la preghiera cristiana non è diretta e ordinata all’uomo, il suo fine è dare gloria a Dio, invocare la sua totale vicinanza, la sua completa manifestazione: “Cercate il regno di Dio e queste cose vi saranno date in aggiunta” (Lc 12,31).
– Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano: siamo passati alla seconda parte della preghiera del Signore. Chi prega ha già messo le basi per una corretta e fiduciosa relazione con Dio, per questo vive nella logica della vicinanza con Dio che è Padre e le sue richieste sgorgano da questo modo di vivere.
Qui “pane” indica il cibo in generale e anche ogni genere di bisogno materiale dei discepoli. Con questa richiesta si chiede che ci liberi dalla disoccupazione o dalla carestia, dalle inondazioni o siccità che distruggono i raccolti, dalle guerriglie che non lasciano lavorare i contadini, si chiede lavoro per lo sposo che deve mantenere la famiglia, aiuto economico per la madre abbandonata, protezione per l’anziano.
Il discepolo, che sta pregando così, è cosciente di non avere molte sicurezze materiali per il futuro, neppure il cibo quotidiano. Il Padre si prenderà cura di lui: “Non preoccupatevi per la vita, che cosa mangerete; neppure per il vostro corpo, come lo vestirete. La vita vale più del cibo e il corpo più del vestito” (Lc 12,22-23).
– Perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo a ogni nostro debitore: il cristiano sa che è già stato perdonato da ogni colpa per la morte di Gesù. Questo lo mette nella condizione e nell’obbligo di perdonare gli altri, offrendo a Dio la possibilità di dare il definitivo perdono al credente, che è capace di perdonare.
Un cristiano che non fosse in sintonia con la salvezza, che Dio gli ha offerto in Cristo, renderebbe vano il perdono già ricevuto. Ecco perché Luca dice: “perché anche noi perdoniamo”: non vuole mettere l’uomo sullo stesso piano di Dio, ma farlo cosciente che può rovinare l’opera salvatrice di Dio, nella quale il Padre lo ha voluto coinvolgere come elemento attivo, affinché a tutti arrivi il suo perdono sempre gratuito.
– E non abbandonarci alla tentazione: la tentazione provoca uno squilibrio, una tensione che è necessario vincere. Fondamentalmente la tentazione consiste nel tornare ad accettare i valori di questo mondo, il potere, la ricchezza, gli onori… e rinnegare quelli che sono propri di quel nuovo mondo, che è il regno di Dio.
L’amico: Più che di una parabola si tratta di un paragone, che suscita negli ascoltatori una risposta chiara. Alla narrazione “se uno di voi ha un amico…” sarebbe difficile sottrarci, non sentendoci interpellati dalla vicinanza con chi ha bisogno. La richiesta dell’uomo che, in piena notte, riceve un ospite inatteso rispecchia il senso di ospitalità dei popoli antichi. L’uomo che, di notte, aiuta l’amico è la figura del discepolo di Cristo, chiamato a pregare Dio sempre e in ogni luogo, con la fiducia di essere ascoltato. La parabola non ci vuole solo insegnare la perseveranza nella preghiera, ma, soprattutto, la certezza di essere ascoltati. Dio è un Padre misericordioso e fedele alle promesse.
Pesci, serpenti, uova e Spirito: Quello che al Padre non piace, non è l’insistenza o indiscrezione dei figli nel chiedere, ma il fatto che non gli chiedano abbastanza, rimanendo in silenzio e quasi indifferenti con Lui, stando a distanza con mille scuse di rispetto, perché tanto “Lui sa già tutto…”. Dio è un amico e con lui ci possiamo comportare con la fiducia, la libertà e la spontaneità con cui ci dirigiamo a un amico vero, senza paure o convenzionalismi. Dio è certamente un Padre che sa provvedere a tutto quello che si riferisce all’esistenza quotidiana dei suoi figli, e sa anche che cosa è buono per loro e lo sa meglio di noi. Ecco perché Egli dona ai cristiani il dono dello Spirito, l’unico bene veramente indispensabile per le loro vite, quello che, se lo lasciamo agire, ci fa sempre più autenticamente figli nel Figlio. All’immagine di Dio-Padre Gesù aggiunge quella di Dio-Amico.