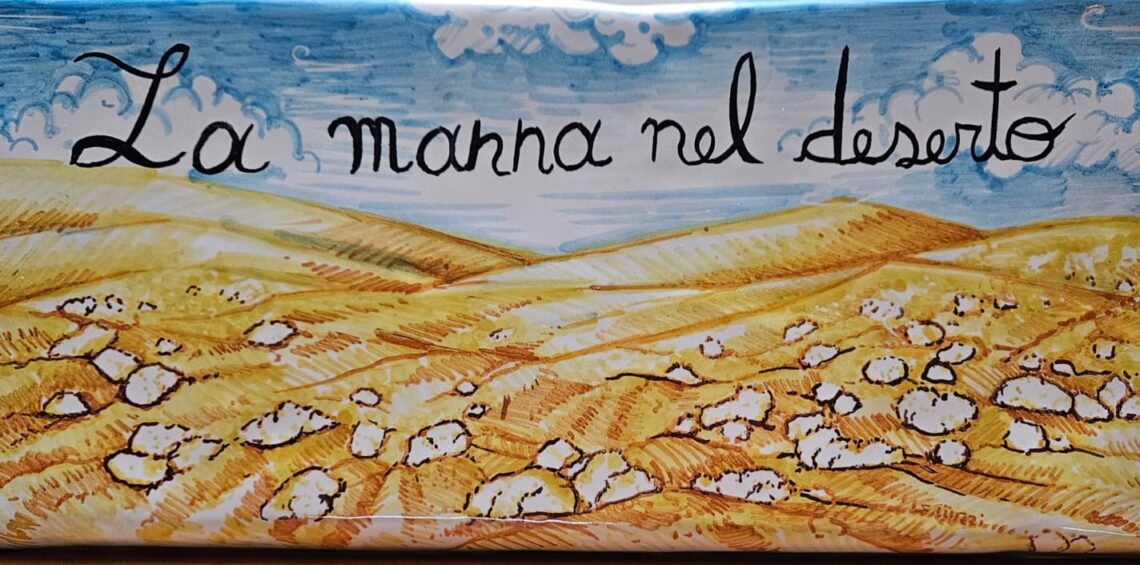
Meditiamo sulla Parola – XXII domenica tempo ordinario anno C
Lc 14,1.7-14
La cornice narrativa di questa pagina evangelica è un contesto conviviale in casa di uno dei capi dei farisei.
Luca ritrae i farisei in maniera discordante all’interno dell’intero testo evangelico: da un lato come coloro che criticano l’operato di Gesù e i discepoli perché non seguono le “tradizioni dei padri”, dall’altra li descrive come maestri del popolo che invitano a pranzo Gesù (Lc 7, 36; 11, 37; 14,1) e gli offrono il loro aiuto quando si trova in pericolo (“In quel momento si avvicinarono alcuni farisei a dirgli: «Parti e vattene via di qui, perché Erode ti vuole uccidere».” Lc 13, 31).
La pagina evangelica è inserita proprio nell’ultimo dei tre banchetti a cui Gesù è invitato, si tratta del pranzo del sabato che aveva luogo dopo la liturgia sinagogale, verso mezzogiorno. Il banchetto è il luogo per eccellenza in cui vivere le relazioni e il confronto, è il luogo in cui rafforzare i legami all’interno dei gruppi sociali e in cui concludere affari. Con l’ingresso di Gesù al banchetto si instaura subito una relazione, una corrispondenza di sguardi che vengono definiti da verbi specifici e differenziati, descrivendo l’intenzione nascosta sotto il semplice atto di volgere lo sguardo.
I primi sono i convitati che osservano Gesù nel suo ingresso, poi è Gesù che osserva i convitati.
Le due frasi in cui avviene questo scambio sono:
– “essi stavano ad osservarlo” (Lc 14, 1);
– “notando come sceglievano i primi posti” (Lc 14, 7).
Analizzando il testo greco possiamo comprendere quali siano le posizioni dei farisei: il verbo utilizzato dall’autore è parateréo, verbo composto formato da teréo che significa osservare, scrutare, ma anche spiare preceduto dalla particella parà che indica un movimento (verso, presso, contro); questo verbo ci indica che i farisei vedono Gesù e lo osservano, lo guardano attentamente, quasi lo sorvegliano durante il pranzo.
Luca per Gesù usa il verbo epécho, anche questo composto: da écho, verbo che significa avere, ma che assume molteplici significati e in questo caso ha l’accezione di rivolgersi, dirigersi e dalla particella epi che significa sopra. Gesù dirige il suo sguardo letteralmente “sopra” di loro, ma non per spiarli, ma per vegliare su di loro, vegliare sulle loro azioni. Un altro significato che ha il verbo epécho è quello di attendere, indugiare. Gesù rivolge sempre lo sguardo verso di noi, con l’atteggiamento di chi vigila, ma anche di attesa, attende le nostre azioni, attende che noi decidiamo come comportarci di fronte alle scelte della vita.
Gesù, infatti, attende che i commensali scelgano i propri posti.
Qui troviamo un altro punto e un’altra parola che ci fa comprendere la reazione di Gesù ed è protoklisía che significa letteralmente “primo posto a mensa”, i convitati cercano tutti i posti d’onore, nessuno cerca un semplice posto o si interroga su quale posto sia giusto che occupi.
Gesù interviene descrivendo quelle che potremmo chiamare le regole del Galateo dell’umiltà, terminando in linea con il libro dei Proverbi (libro in cui ci sono istruzioni e guida per la vita):
Pr 25, 6–7
Non esaltarti davanti al re,
non metterti al posto dei nobili.
Perché è meglio sentirsi dire: “Sali qui”,
che essere degradati al cospetto dei grandi.
La chiosa finale di Gesù (Lc 14, 11: “Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato”) è sottolineata dal fatto che è incorniciata da altri due avvenimenti in cui ribadisce lo stesso concetto: nel capitolo precedente in Lc 13, 30 “Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi” e poco più avanti in Lc 18, 14 “[…] chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato”.
Della seconda parte della lettura, in cui Gesù si rivolge a colui che lo ospita e gli consiglia di invitare gli ultimi che sono impossibilitati a entrare nel meccanismo di reciprocità e di contraccambio (nel testo la parola indica proprio il ripagare, rendere il favore praticamente), è interessante sottolineare il suo porre l’attenzione nel cercare una ricompensa “alla risurrezione dei giusti”.
Questa ultima espressione ci parla della escatologia ebraica. Su questo punto è illuminante il paragrafo 1 del capitolo 10 di Sanhedrin (Sinedrio), uno dei dieci trattati del Seder Nezikin (Ordine dei Danni) una sezione della Mishnah (lett. “studio a ripetizione”) che tratta dei danni civili e penali, nelle procedure giudiziarie:
Tutto il popolo ebraico, anche i peccatori e coloro che sono passibili di condanna a morte imposta dal tribunale, hanno una parte nel Mondo a Venire, come è affermato: “E anche il tuo popolo sarà tutto giusto, erediterà la terra per sempre; il germoglio della mia piantagione, l’opera delle mie mani, affinchéé il mio nome sia glorificato” (Isaia 60:21).
Questa frase ci fa comprendere come la scelta del posto e l’invitare gli ultimi siano due volti della stessa medaglia: Gesù veglia su di noi e attende le nostre azioni e le scruta in maniera vigile invitandoci a compiere il possibile per poter ottenere il nostro giusto posto nel Mondo a Venire che ci attende.