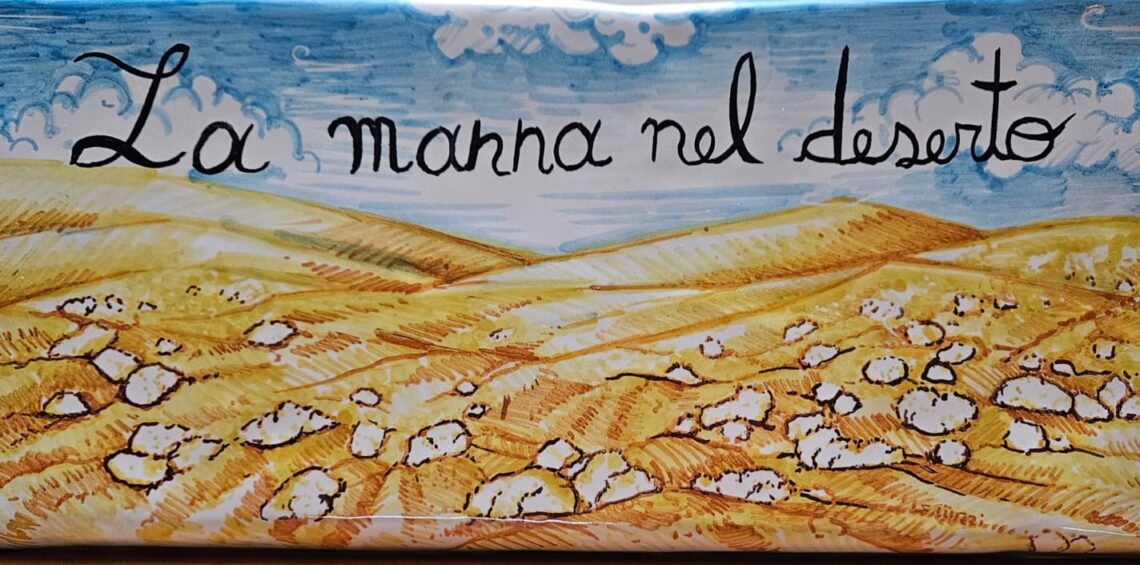
Meditiamo sulla Parola – XXIX domenica tempo ordinario anno C
L’argomento del vangelo di questa domenica è la preghiera certo, ma anche, forse soprattutto, il rapporto fra questa e la fiducia/fede, due realtà che si richiamano l’una all’altra, come scrive p. Lavelli gesuita della comunità di Villapizzone: “La preghiera senza fiducia sarebbe un vuoto esercizio, la fiducia senza preghiera potrebbe essere un pio sentimento che non trova poi forme di realizzazione adeguate”.
Gesù per primo dà il buon esempio, sempre le sue scelte fondamentali sono precedute da un lungo momento (a volte lunghe ore o addirittura un’intera notte) di preghiera, di confronto, di ascolto col Padre.
I personaggi della pagina del vangelo proclamato nella liturgia, sono solo tre:
- il giudice; nel testo greco troviamo una parola (crite’s dal verbo cri’no che vuol dire giudicare, meglio separare, distinguere che a sua volta viene da un verbo ancora più antico, indoeuropeo krey che indica il gesto che si fa per setacciare la farina dai suoi residui inutili;
- la vedova; la parola utilizzata, che’ra, indica non solo la donna che ha perso il marito ma anche, metaforicamente, una città desolata, perché ha perso abitanti e ricchezze, ed è collegata a un senso di vuoto, come una voragine e anche qui c’è un’antica origine dal sanscrito che vuol dire abbandonata;
- l’avversario; il termine antidi’cos significa letteralmente un oppositore in un processo legale.
Di questo avversario non sappiamo niente, né chi sia, né cosa abbia fatto o non fatto alla vedova; sappiamo solo che doveva essere un sopruso e un’azione ingiusta che naturalmente la donna non avrebbe potuto risolvere con le sue sole forze. L’avversario è il simbolo di tutti i prepotenti, di tutti quelli che per la loro forza economica o fisica, non si danno pensiero di ciò che è giusto e ingiusto, ma guardano esclusivamente al proprio interesse. Tutti noi abbiamo probabilmente in mente qualcuno che corrisponda a questa descrizione. Sarebbe opportuno, però, riflettere sulle volte che i nostri comportamenti, anche su cose piccole e insignificanti, hanno ricalcato il comportamento di questo individuo che è “contro giustizia”. Dobbiamo seriamente considerare quante volte siamo stati noi per l’altro avversari che hanno concesso poco o nulla alla giustizia, alla correttezza, alla carità.
Gesù descrive ancora meglio il giudice: non ha paura di Dio e, letteralmente, non si vergogna degli uomini, non li rispetta, non li teme. È un giudice che amministra la giustizia senza crederci, tanto per… Quindi un cattivo giudice non tanto perché corrotto o volutamente di parte, ma perché a lui non importa proprio niente di dove sia il torto o la ragione, lo fa per mestiere, non ha empatia per le vittime, né sdegno verso i colpevoli.
La vedova però è tenace, resiliente, niente affatto rassegnata all’ingiustizia, immaginiamo che nel processo sia la parte debole economicamente e socialmente; sappiamo bene, infatti, quanto poco contassero, a quel tempo, gli orfani e le vedove.
L’insistenza della donna è forte; il giudice per un po’ prova a ignorarla, probabilmente, come accade anche oggi, rimanderà, aggiornerà, dilazionerà, ma con se stesso deve riconoscere che la donna è fastidiosa e lo importuna troppo (letteralmente dice: mi fa fare fatica), questa la traduzione italiana, ma il testo greco è un capolavoro perché troviamo: “mi colpisce allo zigomo”. Nel pugilato, da cui il termine origina, ci vuole, nell’attacco, disciplina e perseveranza e la vedova è proprio come un pugile che “lavora ai fianchi” l’avversario per poi abbatterlo con il colpo decisivo al volto, appunto.
Il commento di Gesù (questa volta fa lui stesso l’esegesi del testo) è una considerazione: se un mascalzone così alla fine cede e concede giustizia e parliamo di un disonesto conclamato, potrà mai fare meno il Padre che sente il dolore e la sofferenza dei figli ultimi e abbandonati salire dalla terra, entrargli nella mente e tramite Gesù anche nel suo stesso corpo? No, farà giustizia prontamente. En ta’kei, tradotto di solito con ”prontamente”, può indicare non solo un’azione svolta celermente, ma anche una cosa che “sicuramente” accadrà e questa seconda interpretazione cambia il senso generale rimuovendo la nostra pretesa di un veloce intervento divino, quindi non un deus ex machina come nella tragedia e nella commedia greca, ma la certezza di un figlio nell’intervento amorevole del padre. Infatti, ciò che Gesù più volte lascia intuire è una cosa diversa: la creazione si basa su un progetto buono e bello, ma libero nella sua dinamica realizzativa, nel senso che la libertà della creatura è sempre salvaguardata a costo di ritardare il compimento dell’opera. Bonhoeffer scriveva: “Dio non esaudisce i nostri desideri, ma le sue promesse”.
Dio è perciò sempre in ascolto, non trascura il grido della vedova, né il grido del sangue di Abele, né si volta davanti alle molte stragi e grida insieme con Rachele, la matriarca del popolo ebraico, che (nella citazione del profeta Geremia, ripresa nel vangelo di Matteo) vede e soffre la triste sorte degli innocenti e non vuole essere con-solata, ma sceglie di essere con-sofferente con le madri in lutto a Rama per l’esilio dei suoi figli, a Betlemme per gli innocenti trucidati e ancora oggi per le molte sofferenze dei piccoli, dei poveri, degli scartati.
La vedova ripete al giudice sempre la stessa semplice richiesta, è il prototipo di chi si fida, perciò pregare è avere ancora una speranza, è non voler lasciare al male l’ultima parola. Ha avuto ragione papa Francesco quando ha insistito nel dire: “La preghiera è il respiro della fede” e la preghiera deve esserci, senza respiro non c’è vita!
Pregare , dice E. Bianchi, è pensare davanti a Dio e con Dio, non è un vuoto borbottio; la preghiera è il “secretum meum mihi” che è la risposta così semplice e profonda che Edith Stein dava a chi le chiedeva di raccontare la sua vita interiore e il suo modo di pregare, perché “il più grande dono che si ottiene è il fatto stesso di pregare cioè di entrare in comunione con Dio, questo è il frutto che la preghiera porta sempre con sé, superiore ad ogni nostra attesa” (commento al vangelo di Luca ad opera dei Comboniani).
Resta l’ultima frase di questa parabola all’apparenza facile, eppure così densa. “Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?”
Compiuto il transito dalla preghiera di richiesta alla preghiera manifestazione di fede, Gesù propone il quesito: “Ne troverò sempre di uomini disposti ad accordarmi tale fiducia?”. È Gesù che parla, ma è anche l’autore Luca che dà voce ancora una volta ai dubbi e alle ansie della sua comunità: dopo la risurrezione e l’ascensione del Maestro il tempo passava, il ritorno del Cristo ritenuto vicino non si realizzava, e alcuni cominciavano a tentennare. L’autore vuole sostenere e rincuorare i suoi; infatti, se spulciamo lo scritto di Luca, più volte il Messia ripete frasi che ci dovrebbero rassicurare: per esempio, al centurione dice “Neanche in Israele ho trovato una fede così grande” e alla donna afflitta da emorragia e al lebbroso samaritano ripete: “Vai la tua fede ti ha salvato”
Forse, con un po’ di audacia, potremmo rispondere a Gesù “Qualcuno lo troverai, anche perché hai detto che te ne basta quanto un granello di senape, in più tu stesso hai amato un gruppo di apostoli che nei fatti ti hanno dimostrato spesso di averne poca di fiducia, eppure ce li hai lasciati come esempio e guide”.
Enzo Bianchi più severo o forse solo più realista scrive a tale proposito:
“Nulla è garantito, nulla è assicurato, e purtroppo ci sono cristiani convinti che la chiesa resterà sempre presente nella storia. Ma chi lo assicura, se neanche la fede è assicurata? Dio non abbandona certo la sua chiesa, ma questa può diventare non-chiesa, fino a diminuire, scomparire e dissolversi nella mondanità, magari religiosa, senza più essere comunità di Gesù Cristo il Signore. La chiamata di Dio è sempre fedele, ma i cristiani possono diventare increduli, la chiesa può rinnegare il Signore. Quando leggiamo il nostro oggi, possiamo forse non denunciare la morte della fede come fiducia, adesione, fede nell’umanità e nel futuro, prima ancora che nel Dio vivente? E se viene a mancare la fiducia negli altri che vediamo, come potremo coltivare una fiducia nell’Altro, nel Dio che non vediamo (cf. 1Gv 4,20)?
La mancanza di fede è la ragione profonda di molte patologie dei credenti e la tentazione di abbandonare la fede è quotidiana e presente nei nostri cuori. Non ci resta dunque che rinnovare la fede, con la speranza nella venuta di Gesù, Figlio dell’uomo, Giudice giusto, e con l’amore fraterno vissuto attingendo all’amore di Gesù, amore fedele fino alla fine per tutti gli umani.”
Noi possiamo solo continuare a fidarci delle parole del versetto 20 dell’Apocalisse “Sì, vengo presto!” “Amen. Vieni Signore Gesù”.