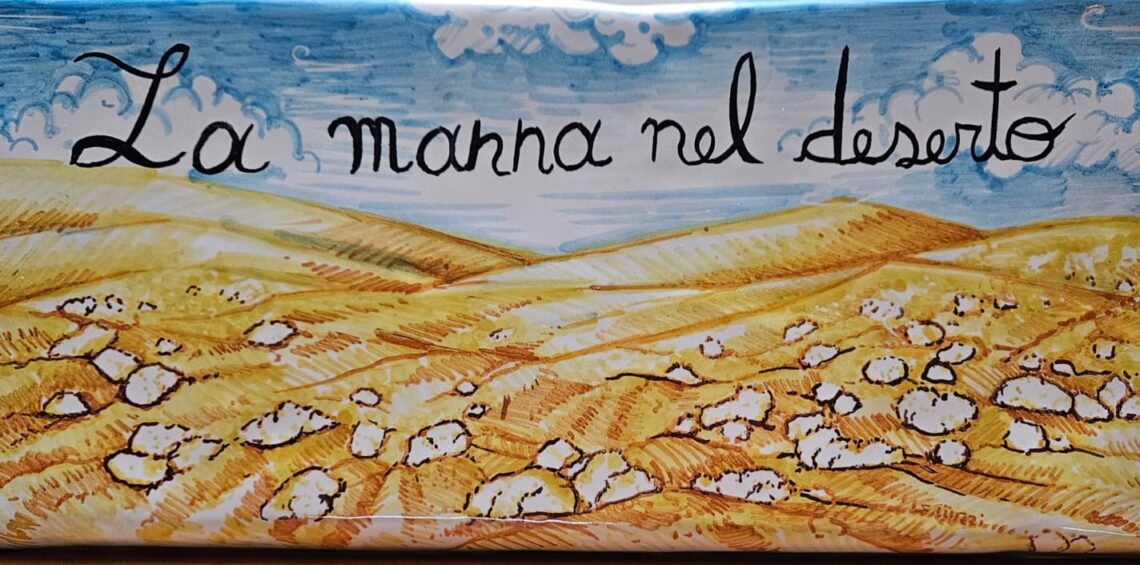
Meditiamo sulla Parola – XXVIII domenica tempo ordinario anno C
Davvero strano il percorso che Gesù sceglie di compiere per arrivare a Gerusalemme, meta del lungo cammino che costituisce la struttura portante dell’intero vangelo di Luca. Gerusalemme si trova a sud e Gesù invece decide di attraversare la Samaria e la Galilea, in un percorso verso nord. Più che reale questo, quindi, appare come un viaggio simbolico.
La Samaria è regione di scismatici e la Galilea terra pagana. Nel suo cammino di donazione totale di sé sulla croce, Gesù viene a cercarci nelle nostre personali Samaria e Galilea, là dove siamo infedeli, siamo o ci sentiamo lontani da Dio.
Strano è anche l’incontro con i lebbrosi che, secondo le norme levitiche, avrebbero dovuto stare lontani dai centri abitati e invece sono in un villaggio. Anche qui bisogna cogliere quegli elementi che ci permettono una interpretazione non letterale. Sono dieci, numero simbolico che indica tutta la comunità: nei dieci lebbrosi è rappresentata tutta l’umanità, malata di una lebbra spirituale che sfigura l’immagine divina impressa in ogni uomo e ogni donna.
Come capiremo più avanti, questo gruppo di lebbrosi è misto, comprende giudei e non giudei che vivono insieme la loro condizione di malattia, isolamento, emarginazione, superando tutti gli ostacoli e le inimicizie derivanti dalle differenze religiose. Ci può essere solidarietà nella malattia, perché ci si scopre tutti fragili. Lo abbiamo sperimentato anche noi pochi anni fa, quando la minaccia di un virus fino a quel momento sconosciuto ci ha fatto sentire tutti ugualmente indifesi, e uno slancio di fraternità è rimbalzato di balcone in balcone, di nazione in nazione dandoci l’illusione che da quel momento in poi tutto sarebbe cambiato. Siamo davvero diventati migliori? Purtroppo no. Eppure, non solo allora ma sempre dovremmo vivere la comune fragilità umana come una esortazione costante alla concordia e alla solidarietà.
I dieci lebbrosi sono i primi, nel vangelo di Luca, a chiamare Gesù per nome, segno del desiderio di stabilire con lui una relazione vitale e profonda. Non chiedono di essere guariti, ma solo un moto di compassione: abbi pietà. E lo sguardo che Gesù posa su di loro è già – come sempre in Luca- uno slancio di misericordia. Un vedere non con gli occhi ma con il cuore. Sembrerebbe quindi contraddittoria nella sua freddezza quell’indicazione ad andare a Gerusalemme dai sacerdoti, come se non fosse compito di Gesù affrontare la loro malattia. Per di più, secondo il libro del Levitico, dai sacerdoti potevano recarsi solo i lebbrosi guariti, proprio per fare certificare la loro avvenuta guarigione. E loro sono ancora malati!
Ma è in cammino che Gesù vuole metterli, perché è in cammino che si guarisce. Inutile aspettare di essere perfetti: è proprio nella nostra miseria spirituale, nella nostra profonda imperfezione che dobbiamo metterci in movimento per dare alle nostre vite la possibilità di essere sanate.
E quei dieci, nonostante il comando apparentemente incomprensibile di Gesù, si fidano e vanno. E si trovano guariti. Ma a questo punto il gruppo si divide. Uno solo, vistosi guarito, torna indietro, dà una svolta alla sua vita, cioè si converte. Il tempio da raggiungere non è più quello di pietra che si erge a Gerusalemme, ma quello che ha appena conosciuto: Gesù. Non cerca più una certificazione, ma una vita piena. Non solo la guarigione, ma la salvezza. E quella la può trovare solo rivolgendo i passi verso Gesù. Da lui torna, si inginocchia, ringrazia: fa “eucaristia”.
Ma non è possibile davvero fare festa se mancano gli altri nove. Non è il loro grazie che Gesù si aspettava, lui che ha sempre esortato a fare il bene senza attendere nulla in cambio. La sua delusione nasce, piuttosto, dalla constatazione che si sono accontentati di essere “guariti” invece di essere “salvati”, troncando il loro percorso di fede che è rimasto incompleto. Saranno pure giunti a Gerusalemme, ma così avranno compiuto per intero solo l’itinerario fisico, non quello spirituale. Solo un samaritano, straniero, con altre tradizioni e altra mentalità, libero da norme giuridico-religiose bloccanti, ha saputo fare una scelta personale, diversa dalla maggioranza. A lui Gesù ridà dignità rimettendolo in piedi e, ancora una volta, gli ordina di mettersi in cammino, perché una vera “eucaristia” non può che sfociare in una vita che diventa annuncio e testimonianza di gioia.
La sua “lode a gran voce” dovrebbe risuonare anche nelle nostre celebrazioni “eucaristiche”, cioè di “ringraziamento”. E dovremmo sentire malinconia per i banchi che rimangono vuoti accanto a noi, disertati non più dai nove ma dai tanti fratelli che non sentono l’esigenza di tornare a ringraziare Dio.
E quando alla fine il celebrante, come Gesù, ci dice “andate” dovremmo impegnarci a tradurre la liturgia in vita. Una vita che non sa tornare a ringraziare il Signore per i doni ricevuti è una vita che non conosce la sua origine e il suo significato. Una “eucaristia” che non diventa vita è un rito sterile. Solo insieme, come l’inspirazione e l’espirazione del respiro, generano l’energia per una esistenza piena.
Saper dire grazie a Dio. Saper dire grazie ai fratelli. In quel “grazie” riconosciamo i doni ricevuti. E ci scopriamo debitori. Sì, debitori. Sempre e comunque. Perché nulla di quello che abbiamo lo dobbiamo dare per scontato.